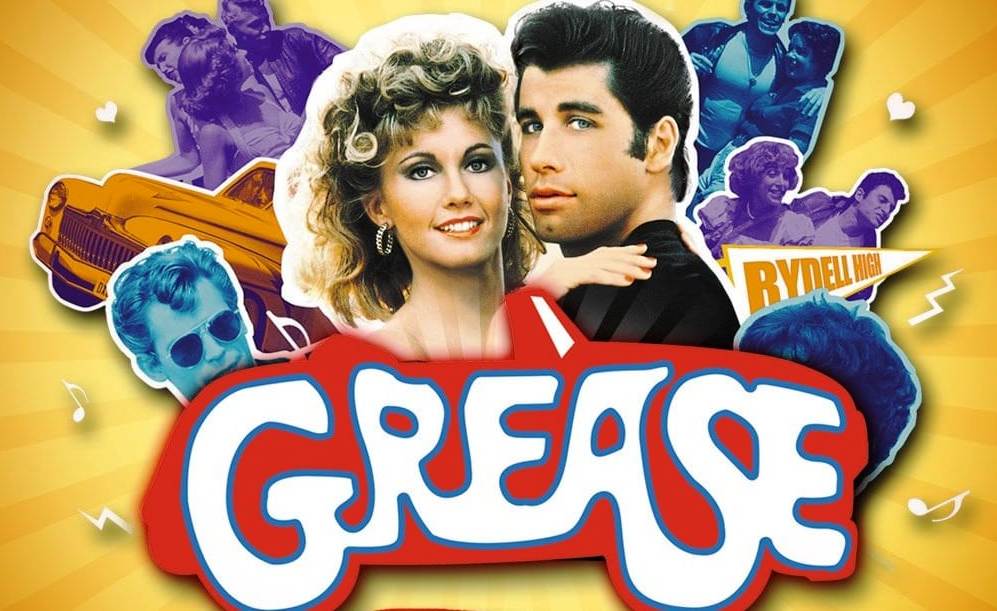
Filosofia di John Travolta – 2010
Eidos cinema e psyche, 19
di Alberto Angelini
La danza è simbolo della liberazione dai limiti del mondo materiale e può divenire concreta manifestazione della vita spirituale. In essa ritmo, melodia e parola si sintetizzano nel corpo umano, nell’ambito di uno spazio e di un tempo proposti dal danzatore. In quanto ordine ritmico, la danza degli dei e degli eroi mitici concorre all’organizzazione e alla regolazione ciclica del mondo.
In senso generale, le danze rituali sono un modo per ristabilire, mentalmente e antropologicamente, i rapporti tra terra e cielo, sia che esse invochino la pioggia, l’amore, la vittoria o la fertilità. Nella danza può trovare spazio la potente espressione del dramma, perché è il solo momento in cui l’uomo rifiuta il ritmo deterministico della natura e propone un proprio ritmo liberatorio, capace di allargare i limiti della dimensione umana.
Storicamente, in ciò, i danzatori hanno sempre cercato di avvicinarsi agli dei. Secondo Luciano di Samosata le danze “traducevano in movimenti espressivi i dogmi più misteriosi della religione, i miti di Api e di Osiride, le trasformazioni degli dei in animali e soprattutto i loro amori”.
Anche per Platone la danza era di origine divina e, prima di essere movimento, era segno e significato. Essa non obbediva unicamente a esigenze di grazia e di ordine. Per meglio esprimere il proprio messaggio, essa poteva esulare dalle evoluzioni ritmiche per ricercare, soprattutto nelle cerimonie dionisiache, disordini, opposizioni e manifestazioni spontanee.
La simbolica lotta fra il disordine pulsionale di Dioniso e l’organizzazione regolatrice del ritmo costituisce, quando il risultato è armonico, la danza perfetta.
Questo intravediamo quando John Travolta, con pantaloni “a zampa d’elefante” bianchi, giacca bianca, gilet bianco e camicia scura balla sulle note di “More than a woman” dei Bee Gees, nel film musicale La febbre del sabato sera (1977), interpretando il personaggio di Tony Manero. Sembra, nella danza, che il protagonista esprima un armonico contatto con le forze pulsionali dell’inconscio e non abbia quindi timore, garante l’armonia, di abbandonarsi a quell’”entusiasmo” che, nel passato, testimoniava la presenza fisica e mentale di Dioniso.
L’intero film è un pretesto per consegnare alla storia del cinema le sequenze di questo ballo. Contemporaneamente, si ricordano, come dotate di un buon effetto, alcune scene girate nei pressi del ponte di Verrazzano.
La trama è semplice, tuttavia il film riesce a rappresentare un certo spirito giovanile che permeava gli anni settanta e pretende di raccontare la vita dei giovani dell’epoca dal punto di vista di Tony Manero. Quest’ultimo è un ragazzo, di origini italiane, che vive in un sobborgo di New York. La sua vita è basata sul ballo e sul sabato sera, quando si scatena in pista. Nelle discoteche da lui frequentate, Tony è il re; tutte le ragazze impazziscono per lui e gode del rispetto di tutti. A modo suo è un personaggio eroico; un eroe della danza e in discoteca, inevitabilmente, conosce Stephanie. Poi la vicenda è, più o meno, scontata: si innamoreranno e riusciranno a vincere la gara di ballo, pur non avendolo pienamente meritato. In seguito, le esperienze di vita porteranno il protagonista a rivedere l’atteggiamento superficiale adottato in passato.
Sul piano collettivo, lo stile di vita del gruppo di amici, caratterizzato da machismo e da un forte spirito di concorrenza, porterà fatalmente alla morte di uno di loro.
La trama vorrebbe trattare anche tematiche serie, toccando problemi giovanili tuttora attuali, come l’emigrazione, l’uso di stupefacenti nelle discoteche e la violenza tra bande.
Il Travoltismo esploso nell’immaginario collettivo con La febbre del sabato sera, prosegue l’anno dopo, nel 1978, con Grease, dove Travolta rimane l’eroe, ma la vicenda esprime toni più corali e legati alla presenza del gruppo.
Non si cerchi, qui come nel film precedente, uno spessore nella trama o qualche traccia di vero pathos. Il film è un pretesto per immergere lo spettatore nella dimensione viscerale del ritmo e del ballo. Si cerca l’armonia, la Gestalt della frase musicale che inizia e si conclude perfettamente lasciando il pubblico con un senso di appagamento e sazietà. Questo obiettivo viene raggiunto; il film è un successo e alcune delle sue parti divengono “pezzi” della storia del cinema. E’ spettacolo puro che, ancor più della pellicola precedente, si astrae dalla storia presa a pretesto; è rappresentazione, non realà.
L’atmosfera di Grease, a differenza del precedente film, si caratterizza per una dimensione ancor più gruppale. Travolta è un protagonista che danza sullo sfondo di un gruppo in movimento e quest’ultimo viene portato, dalle vicende filmiche, fortemente in primo piano.
Aleggia, nel film, una eco di antichi riti collettivi; la danza dei dervisci, o anche la danza del sole dei Sioux, dove esisteva un rapporto tra il movimento dei danzatori e quello delle sfere planetarie. E’ un ballare di gruppo per richiedere buona sorte e benedizioni celesti.
Nel film non ha senso cercare la verità oggettiva. Va gradita piuttosto la verosimiglianza; vale a dire, anche se la citazione è fin troppo nobile per la materia trattata, l’unico obiettivo al quale, secondo la Poetica di Aristotele, può essere finalizzata la poesia.




