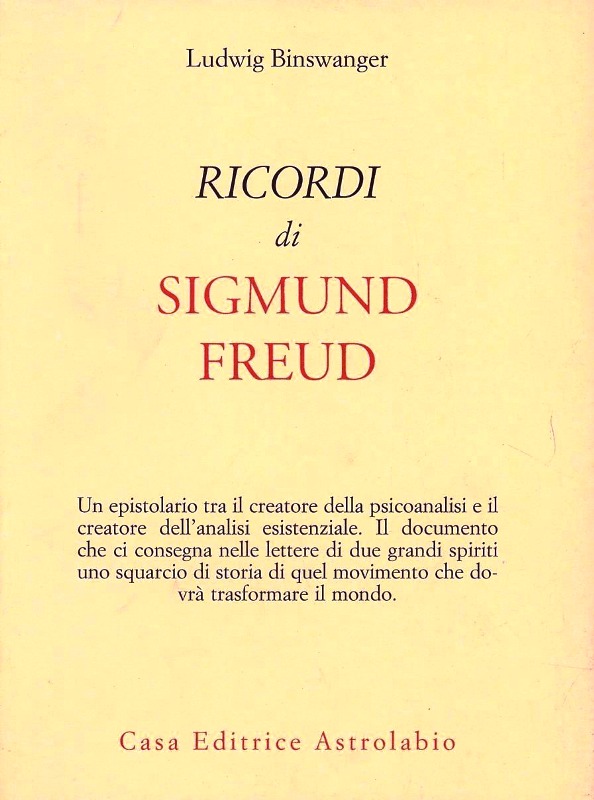
Freud e Binswanger
5/2/2016 – “Apprezzo il Suo tatto nel contraddirmi…naturalmente ancora non sono d’accordo con Lei”. Così Freud, nel 1936, scriveva a Binswanger, commentando la sua dichiarata esigenza di completare la psicoanalisi con contributi religiosi e filosofici. Già da un quarto di secolo, malgrado la notevole differenza nelle vedute scientifiche, i due uomini erano, comunque, legati da una stretta amicizia. Binswanger, di formazione psichiatrica, fu estremamente sensibile alla lezione psicoanalitica di Freud. Contemporaneamente, subì l’influsso della fenomenologia di E. Husserl, protesa verso un “ritorno alle cose stesse” e, ancor più, della filosofia esistenziale di M. Heeidegger. La riflessione proposta in Delirio, come le sue restanti opere, trovano radici in queste correnti di pensiero. Nella “analisi esistenziale”, di cui Binswanger è stato il massimo esponente, prevale l’attenzione verso il mondo individuale e irripetibile del malato. Storicamente, ciò costituisce una reazione alla generale e mastodontica classificazione dei disturbi mentali proposta, alla fine dell’ottocento, da E. Kraepelin. Lo scopo di Binswanger è una ricognizione dei modi di essere dell’uomo, nel mondo e con gli altri, di cui le malattie mentali costituiscono solo una possibile manifestazione. Il metodo consiste in un approfondimento dei “dati” provenienti dalla clinica, deliri compresi. Non prevale l’individuazione di qualche rapporto di causa-effetto né la ricerca di una sotterranea sintonia emotiva. Emerge, invece, l’aspirazione a osservare e descrivere l’essere nel mondo della presenza alienata. Il fine terapeutico è in sottordine rispetto al desiderio di conoscere. Per questo l’analisi esistenziale, anche se non va considerata uno strumento di cura, risulta un utile mezzo di approfondimento al servizio della psicopatologia.




