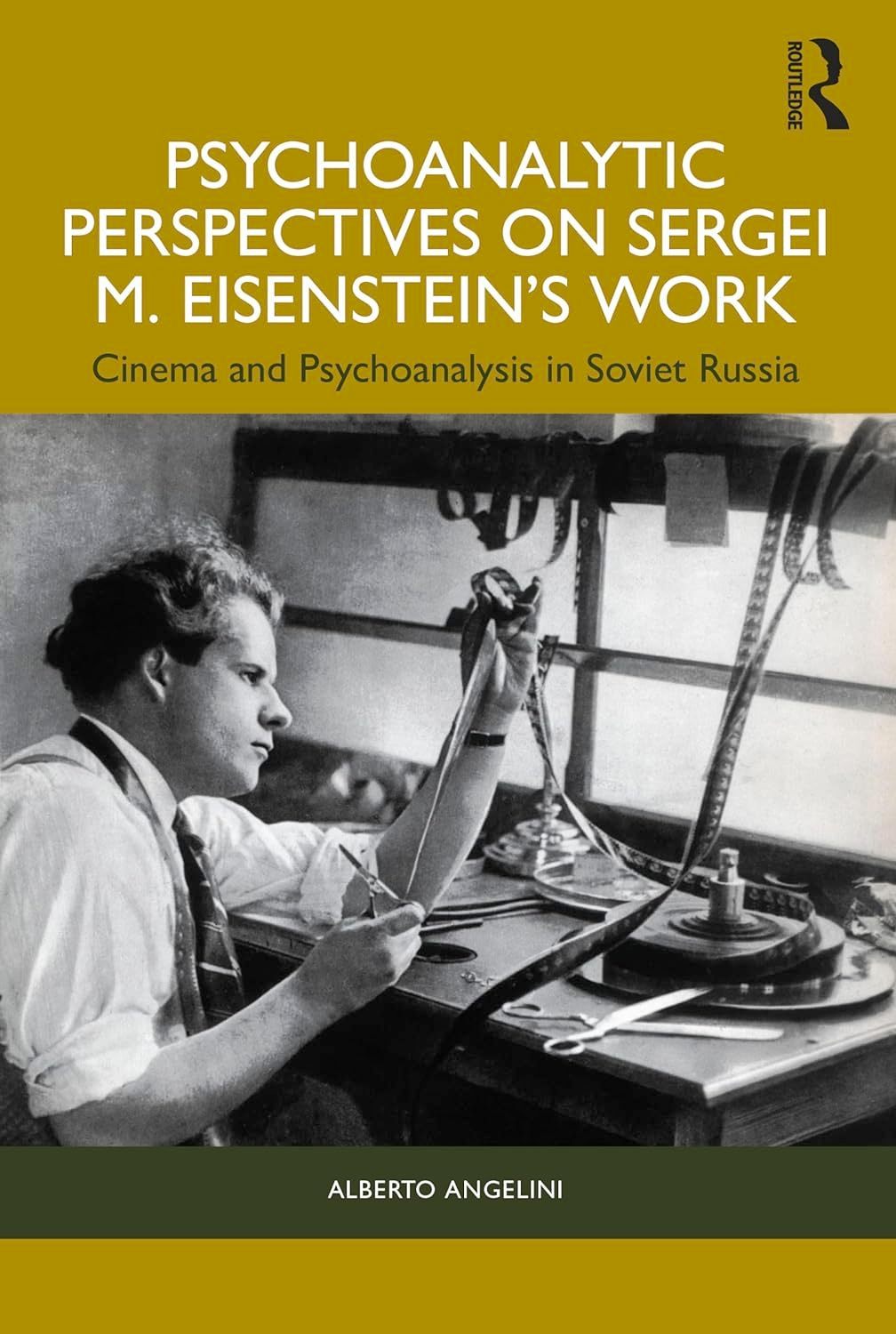Il Cinema Sociale
(Pubblicato sul n. 37/2017 di Eidos)
La rivista Eidos cinema psyche e arti visive nacquenel 2004 per iniziativa di alcuni psicoanalisti junghiani e freudiani, estranei a pregiudizievoli separazioni teoriche o a suddivisioni per scuole di appartenenza e interessati a far dialogare il cinema con la psicoanalisi. Veniva proposto un progetto, culturale e editoriale, rivolto sia agli specialisti del settore, sia agli amanti del cinema e delle arti visuali. L’idea ispiratrice consisteva nel desiderio di offrire, per quanto possibile, una “lettura psicoanalitica” dei due argomenti. Da allora a oggi, con cadenza quadrimestrale, ogni numero ha sempre affrontato un tema centrale, capace di costituire un filo rosso di collegamento nella scelta dei film presentati.
Sul piano editoriale, la rivista si suddivide in varie sezioni. Cinema e psiche è uno spazio per articoli teorico-metodologici di approfondimento psicoanalitico. Nel film è l’ambito in cui trovano posto pellicole di ogni epoca. L’altro film propone la parte più nascosta dell’ideazione filmica; quella che ha a che fare con la storia del regista e con il film, dal punto di vista dell’inconscio. L’intervista è il settore in cui la rivista dialoga con autori, sceneggiatori e registi. Cult è la parte in cui si vuole ripercorrere la storia del cinema. Infine vi è un’area a sé stante, dedicata alle molteplici forme in cui si propongono, oggi e nel passato, le Arti visive. Accanto a queste sezioni, che definiscono l’impianto strutturale di Eidos, se ne alternano altre legate ad eventi significativi, per il rapporto attuale fra psicoanalisi e cinema. Ci si riferisce, in particolare, ai festival e alle rassegne cinematografiche dedicate alla psicoanalisi ed organizzate dagli stessi psicoanalisti, con il frequente patrocinio delle istituzioni psicoanalitiche. Va, in quest’ambito, ricordato il Festival Europeo di Cinema e Psicoanalisi di Londra, con cui la rivista Eidos, da anni, mantiene una proficua collaborazione, pubblicando cronache, atti e filmografie. A ciò si aggiunga la rassegna “Cinemente”, promossa dalla Società Psicoanalitica Italiana e dal Centro Sperimentale di Cinematografia, a Roma.
Fin dall’inizio, l’attenzione, offerta dagli autori di Eidos al cinema, fu catturata da temi di rilevanza sociale. La storia, la politica, la questione femminile, la paternità, l’invecchiamento e il dramma delle dipendenze apparvero, autorevolmente, come discorsi conduttori di differenti numeri della rivista, assieme ad altre similari problematiche. Ad esse si affiancarono argomenti più legati, direttamente, al momento espressivo, come la musica, la danza e la poesia; ma anche in quest’ultime emergeva, inevitabilmente, il segno delle trasformazioni sociali. Negli anni recenti, in particolare, la sensibilità di Eidos è stata attratta dal tema delle migrazioni e da tutti i complessi fenomeni ad esse collegati. La rivista ha partecipato a diverse iniziative e ne ha promosse altre, sempre attinenti a questi argomenti. Attualmente, in modo specifico, l’aspirazione è quella di portare, in chiave psicoanalitica e sempre in ambito cinematografico, un pur modesto, contributo al dibattito sociale relativo alle trasformazioni epocali indotte dalle migrazioni. È un effetto dei tempi: l’argomento si impone da sé e il cinema gli sta dedicando sempre maggiore attenzione; quindi è logico ed opportuno che anche il pensiero psicoanalitico si interessi ad esso. La psicoanalisi viene, in questo caso, chiamata ad occuparsi di ciò che la critica cinematografica ha definito “Cinema sociale”. Di conseguenza, una rivista come Eidos è stata, molto, attratta da quest’ambito di riflessione.
Non si deve, tuttavia, dimenticare che, storicamente, è esistito un intenso dibattito sul significato e sulle competenze del Cinema Sociale. Allo stato attuale, questo dibattito è sempre forte e, di fatto, implica, com’è ovvio, la domanda inveterata e necessaria sul significato storico e psicologico del cinema.
Chiedersi cosa significa Cinema Sociale vuol dire, in effetti, domandarsi cosa dobbiamo intendere per cinema. Non si deve pensare al mero apparato di produzione delle immagini, ossia al solo sistema produttivo con i suoi meccanismi tecnologici ed espressivi, i suoi ruoli e le sue, più o meno celebrate, figure professionali. Parimenti, il cinema non è il pur decisivo repertorio delle opere che hanno segnato periodi e modi di crescita di intere generazioni di spettatori. Esso non può venire considerato soltanto la collezione delle immagini sonore che hanno attraversato più di un secolo; anche se questo è un risultato della massima dignità, nella rassegna delle produzioni artistiche del mondo sociale.
Il cinema va considerato un fenomeno ampio e stratificato nell’ambito di un sistema socio-culturale complesso. In esso, la produzione e il consumo si intrecciano in modi diversi, che vanno oltre la normale impresa economica ed espressiva, collegandosi a forme e idee sul mondo, sul reale e sull’immaginario.
Il cinema produce azioni molteplici, che si riverberano su altre forme di comunicazione, su modelli formativi e di apprendimento, su comportamenti individuali e di gruppo, su idee generali relative al mondo e alla realtà. Come conseguenza individuale, il cinema agisce sulle qualità specifiche della nostra soggettività anche nell’arco di intere esistenze.
Appare quindi evidente come l’intreccio fra cinema e realtà sociale sia stato e sia un elemento inestricabile nello sviluppo di questo mezzo di comunicazione di massa.
Nella storia del cinema si individua un periodo in cui nacque il cosiddetto “Cinema sociale”. Dal 1934 al 1947, negli Stati Uniti si verificò una intensa produzione di film a tematica sociale. Ciò era una conseguenza della depressione economica, che imperversava a quel tempo. Dopo l’ingresso degli USA nella seconda guerra mondiale e la ripresa economica e dell’occupazione, principalmente in imprese ed industrie belliche, il Cinema Sociale fu momentaneamente accantonato; ma rinacque all’indomani del conflitto mondiale.
Nella seconda metà del novecento, però, si è diluita questa voglia di mostrare l’impatto dei problemi sociali, perdendo il senso essenziale di questo stile. Fortunatamente di recente con la sconfinata crescita tecnologica ed il conseguente abbassamento notevole dei costi di produzione, grazie anche all’avvento del digitale, si è assistito ad una nascita esponenziale di cortometraggi e documentari, ma anche lungometraggi, di vera e propria denuncia, riflessione ed inchiesta su svariate tematiche sociali, nati principalmente dall’esigenza di raccontare eventi e situazioni che la tv ormai non racconta, per volontà o mancanza di spazi idonei. Attualmente, per Cinema Sociale, si intende un cinema che racconta e analizza la condizione umana di fronte al Potere e alla Storia e che si oppone alle verità imposte dalla “Storia ufficiale” offrendo, grazie alla forza stessa del suo linguaggio, altri e inediti punti di vista, altre modalità di narrazione e di rappresentazione del reale. Un cinema cui spesso sono state assegnate varie etichette, come quelle di cinema di impegno civile o di denuncia.
Il Cinema Sociale continua a cercare uno sguardo diverso sulle persone, sulle cose e sulle relazioni umane, opponendosi all’omologazione televisiva planetaria, come pure a un’immagine cinematografica sempre più autoreferenziale, che si accontenta di sé stessa e della propria valenza tecnologica. Un cinema che, nel margine e nel “fuori campo”, insegue il nesso fra fenomeni sociali e culturali, in un mondo dove il rischio più evidente è la tendenza a utilizzare uno sguardo ed un pensiero unico. Nonostante i condizionamenti, politici ed economici, il cinema contemporaneo continua a raccontarci la cultura dei popoli e le sue contraddizioni.
In Italia, da alcuni anni, tra vari progetti in atto, è presente l’interessante iniziativa del Social World Film Festival. Ovvero la Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense che, nel 2017, raggiungerà la settima edizione.
La suddivisione in generi di interesse sociale, offerta da questo Festival, è esemplificativa ed utile per chiunque si avvicini a questa tematica cinematografica. Considerando anche il grande numero di produzioni, in quest’ambito, il Social World Film Festival le ha ripartite in quattro settori.
1) “Diversity”. La diversità alla base della vita: uomini, donne,
bambini, giovani, anziani, bianchi, neri, poveri, disabili.
2) “Environment”. L’ambiente: delicata e preziosa casa unitaria di
uomini, animali e vegetali.
3) “Human Rights”. I diritti umani odierni: libertà, schiavitù,
tortura, sicurezza, pena di morte.
4) “Culture and Art”. L’arte e la cultura come fondamenta della
storia passata, presente e futura.
Di fatto, nell’arco degli ultimi dieci anni, in diversi continenti, si sono realizzati film che affrontano alcuni dei problemi più scottanti del mondo contemporaneo. Si è fatto riferimento alla migrazione, ma anche sono da considerare la multiculturalità e il razzismo, i temi del lavoro e del suo ruolo collettivo, la violenza istituzionale, la corruzione, il degrado sociale ed altro.
Tuttavia, la tematica della migrazione va considerata uno degli argomenti contemporanei più densi di significato, nell’ambito del cinema sociale. Il fenomeno, negli ultimi tempi, ha molto attratto l’attenzione, proponendosi sul piano politico e ideologico; contemporaneamente esso è divenuto oggetto di riflessione per il mondo della cultura e dei media. È opportuno che la psicoanalisi approfondisca l’argomento, non solo perché il cinema ne fa la cronaca e ne espone, creativamente, le molte caratteristiche ma, soprattutto, perché questa realtà determina trasformazioni radicali. I flussi migratori attuali stanno alimentando mutamenti epocali che cambieranno, completamente, il volto della nostra società, innescando reazioni, soggettive e collettive, difficili e controverse. La dimensione mentale di tutto ciò è, inevitabilmente, materia psicoanalitica. Quel che accade nella mente dei migranti e nella mente di coloro che vivono sulla terra che li riceve è problematico e fonte di riflessione.
Fin dalla seconda metà del secolo scorso, la psicoanalisi ha iniziato ad elaborare una riflessione approfondita sulle migrazioni (Cfr. Grinberg L. & R., 1999), anche se in modo non sistematico. Sono emersi vari campi d’indagine. I miti, da Adamo ed Eva, all’enigma della Sfinge, a Babele, in forme diverse, hanno sempre evidenziato la spinta umana verso la conoscenza o, semplificando, verso la curiosità. Ovviamente, il significato di questi miti deve essere, oggi, collocato in un contesto storico dove la mobilità geografica è determinata, prima di tutto, da potenti contraddizioni economiche e politiche che penalizzano, principalmente, il sud del pianeta.
Peraltro non è semplice, dalla prospettiva psicoanalitica, definire chi sono i migranti. Prescindendo dalla fitta schiera di migranti economici, vi è anche un numeroso gruppo di persone esiliate o rifugiate, per motivi politici o religiosi. Tutti costoro si possono dividere in due grandi categorie: coloro che preferiscono rimanere in contatto con le persone e i costumi conosciuti, faticando nel distaccarsi dai luoghi familiari e coloro che accettano, o addirittura preferiscono, luoghi e rapporti nuovi.
Nei casi migliori, l’intenso desiderio di andar via ed avere nuove esperienze può riflettere una idealizzazione di ciò che è avvertito, contemporaneamente, come ignoto e proibito.
Nella maggior parte delle situazioni, però, la migrazione è determinata dall’esigenza di sottrarsi a drammatiche, o addirittura persecutorie, situazioni sociali ed economiche. In questa eventualità, mentalmente, il soggetto si risolve alla fuga da ciò che prima era familiare e poi è divenuto dannoso. In questi casi, per chi se ne va, i sentimenti possono assumere varie colorazioni, a seconda dei desideri, dei progetti e delle sofferenze. Inoltre, le emozioni sono soggette a repentini mutamenti o, addirittura, rovesciamenti, perché nei fatti, sul piano concreto, l’individuo si trova “sul filo del rasoio” (Grinberg L., 1978). Quando il dolore psichico, di tipo depressivo, non può essere più tollerato, esso viene sostituito da un senso di profonda persecuzione. Inoltre, affetti molto forti possono essere isolati, bloccati e repressi.
In alternativa vi è la reazione maniacale, in cui il dolore e la sofferenza vengono negati e sostituiti da sentimenti di trionfo su coloro che rimangono, ora percepiti come limitati e incompetenti. Difese come il diniego, l’annullamento e l’isolamento degli affetti sorgono, generalmente, quando forti sentimenti di colpa nei confronti di quelli che rimangono si aggiungono al dolore della separazione. Molto raramente l’individuo riesce a elaborare l’esperienza della migrazione, integrando i sentimenti negati e scissi, in modo graduale ed equilibrato. Essere un emigrante è molto diverso dal sapere che si sta emigrando, accettando in modo pieno e profondo la realtà di questa condizione.
Anche l’arrivo, sul piano psicologico, non avviene in un tempo determinato. Occorrerà un lungo periodo, dopo aver raggiunto la terraferma, prima di percepire il nuovo paese come concreto e solido. Nel primo periodo dell’esperienza dell’immigrazione, la mente dell’individuo è occupata dalle persone e dai posti che ha lasciato ed è spesso piena del desiderio di rincontrarli. Il nuovo arrivato deve assorbire inediti, complessi, codici di comunicazione e può avere la sensazione di venire inondato da messaggi caotici. A volte ciò determina il cosiddetto “Shock-culturale” (Garza-Guerrero, 1974). In questo caso, possono verificarsi regressioni ai livelli più primitivi di comunicazione, che trovano, frequentemente, espressione in elementi primordiali e strutturanti, come il cibo (Segal H., 1978).
Solo dopo diverso tempo, l’immigrato inizia a riconoscere sentimenti precedentemente dissociati o negati e diviene in grado di sopportare i “dolori della crescita”, ovvero l’evoluzione del processo migratorio. Allo stesso tempo, egli diventa, maggiormente, disponibile rispetto alla lenta e progressiva incorporazione di elementi della nuova cultura. L’interazione fra mondo esterno e interno diviene, pertanto, più fluida. Un grande ruolo è giocato dall’apprendimento della lingua. I progressi, in tal senso, si fermano a un certo livello, che varia da persona a persona, in base al compromesso fra l’imposizione dell’ambiente e la resistenza interna.
Infine, auspicabilmente e nel migliore dei casi, la persona recupera il piacere di pensare e desiderare, assieme alla capacità di fare progetti per il futuro. Il lutto per il paese d’origine è stato elaborato, nella massima misura possibile. L’integrazione, della cultura precedente nella nuova, viene facilitata, senza bisogno di rinunciare alla prima per la seconda. Solo a questo punto, si può pensare ad un Io equilibrato e ad un senso d’identità ben sviluppato.
Si può comprendere, tornando al cinema, come quest’ultimo, anche in ambito documentaristico, non abbia potuto, ovviamente, illustrare e sviluppare l’insieme di questo processo, che qui è stato, solo, accennato. Del resto non è compito del cinema affrontare e approfondire, in ambito teorico e descrittivo, le complesse problematiche psicoanalitiche relative alle migrazioni. La cinematografia ha il suo specifico territorio anche rispetto a tematiche sociali. In questo territorio, lo strumento cinematografico ha, ampiamente spaziato, restando nei termini e nei significati del suo linguaggio.
In ambito cinematografico, va constatato che, fino alla fine del secolo scorso, il cinema italiano non è stato particolarmente attento alle grandi trasformazioni che si sono vissute nel paese sui temi dell’immigrazione, dell’accoglienza e dell’integrazione di milioni di stranieri. Solo a metà del primo decennio del 2000 si è iniziato a considerare l’immigrato come soggetto di storie e di cinema. Nelle sale sono giunte vicende di arrivi, di accoglienze, di speranze e di rifiuti; storie ispirate a fatti reali e all’atteggiamento contraddittorio, di emarginazione e di integrazione, della società. Vicende che descrivono come sia possibile solidarizzare con lo straniero e inserirlo, a pieno titolo, nei processi produttivi, mentre egli viene tenuto ai margini di una comunità che è affascinata dalle diversità culturali e dai costumi differenti, ma li considera pericolosi per la propria conservazione.
Molti autori hanno diretto la loro attenzione e i loro sforzi creativi verso il tema della migrazione
Il 2011 è stato un anno straordinario, con quasi 20 pellicole italiane sul tema, di cui due hanno avuto premi speciali alla Mostra del Cinema di Venezia. Dall’esodo dei disperati che fuggono dal Nord Africa narrato in Terraferma di Emanuele Crialese (Premio della Giuria) alla strage di Castelvolturno raccontata in Là-bas di Guido Lombardi (Migliore opera prima), il soggetto preferito dai registi italiani, in quell’anno, è stato proprio l’immigrazione.
Inoltre, le opere presentate a Venezia sull’argomento, in quell’anno, non sono state solo quelle premiate: in tutte le sezioni, oltre una decina di film hanno trattato l’impegnativo tema.
Non è questo l’ambito per offrire una disamina, dettagliata e aggiornata ad oggi, della vasta filmografia relativa all’argomento. Essa occuperebbe molte pagine riguardando opere provenienti da più paesi, soprattutto dell’area europea e mediterranea, maggiormente interessata dal fenomeno dell’immigrazione. Valgano, come unici esempi significativi, in Italia, i film sopracitati, proposti come simboli dei molti lavori cinematografici che, negli ultimi anni, hanno affrontato la questione in forme originali e rilevanti.
A ciò si affiancano le opere di carattere documentaristico e più connotate ideologicamente. In questo caso, sempre come unico esempio italiano indicativo, può essere citato Fuocammare (2016), di Gianfranco Rosi. La categoria contemporanea dei documentari ripropone la grande tradizione documentaristica nata negli anni trenta con le opere di John Grierson e Joris Ivens e offre, come in questo caso, ancor oggi, grandi esempi di un cinema che esplora, antropologicamente e socialmente le sofferenze umane.
In generale, però, è solo attraverso la finzione che il cinema ha saputo, in senso mediaticamente diffuso, condurre a un livello di autenticità e di efficacia espressiva la materia, spesso tragica, della cronaca e della storia. In ciò il cinema sta segnando un momento altissimo del suo sviluppo riuscendo, meglio di ogni altro media, a riprodurre criticamente una così drammatica realtà sociale, sia come documento sia, ancor più, come invenzione poetica.
In questa prospettiva, socialmente mutabile, che guarda verso una cultura cinematografica sempre più densa di nuovi contributi e di proposte interpretative, una rivista come Eidos deve prestare attenzione a questi epocali e controversi momenti d’incontro culturale. Inoltre, essendo Eidos fondata, redatta e gestita da psicoanalisti, il suo miglior contributo sarà quello di non cadere nella rimozione, ma offrire una puntuale e, per quanto possibile, approfondita visione psicoanalitica, riguardo alle molte novità che le incessanti trasformazioni della storia e della società producono, attualmente, nel cinema e nell’arte.
Nota Bibliografica
Grinber L. & R. (1999), “Prospettive psicoanalitiche della
Migrazioe”, in: Bell D. (1999), Psicoanalisi e
Cultura, Paravia Bruno Mondadori, Milano,
20002.
Grinberg L. (1978), “Il filo del rasoio nella depressione e nei
lutti”, in: Psicoanalisi. Aspetti teorici e clinici,
Loescher, Torino, 1983.
Garza-Guerrero A. C. (1974), “Culture-shock: its mourning and
the vicissitudes of identity”, Journal of the
American Psychoanalytical Association,22.
Segal H. (1978), “On symbolism”, International Journal of
Psychoanalysis, 59.