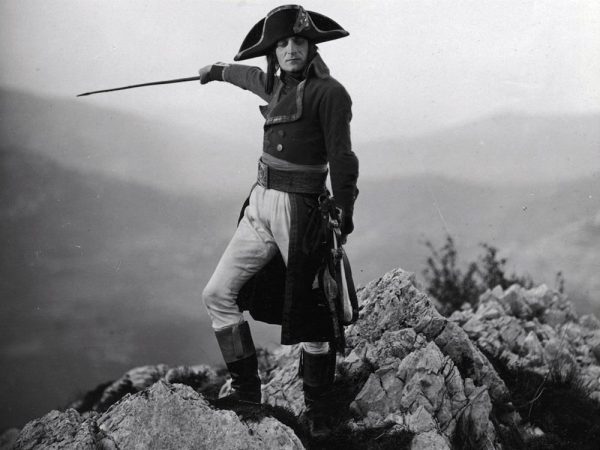Inside Out
Alberto Angelini
Secondo la teoria di Cartesio dell’homunculus, le nostre funzioni percettive ed esecutive sarebbero governate da un piccolo essere, un omuncolo appunto, collocato un gradino al di sopra della nostra coscienza. Ad esempio, nel caso della visione umana, mentre la luce esterna forma una sequenza di immagini sulla retina, l’omuncolo, situato all’interno del cervello, la osserverebbe come se assistesse ad una rappresentazione teatrale. Da ciò l’espressione teatro cartesiano. I detrattori di questa teoria pongono un legittimo quesito: come tale omuncolo vede lo spettacolo? La risposta è ovvia: all’interno del suo cervello c’è un secondo omuncolo che osserva la retina del primo e così via. Il tentativo di spiegare un fenomeno, nei termini dello stesso fenomeno che si vuol spiegare, conduce a un infinito gioco di specchi.
Inside Out racconta la storia di Riley, una ragazzina di undici anni che deve trasferirsi dal Minnesota a San Francisco. L’originalità di Inside Out, film d’animazione, sta nella tecnica narrativa usata per gran parte del film. Quello che accade a Riley viene mostrato tramite cinque emozioni “personificate”, cinque personaggi animati, ovvero omuncoli, che agiscono nella sua mente: Gioia, Tristezza, Disgusto, Rabbia e Paura.
Come proposta psicologica è un pò scarna. Anche accettando l’idea, inquietante, che a governare la nostra mente siano, prima di tutto, le emozioni, le cose andrebbero comunque diversamente. Stando al FACS (Facial Action Coding System) sviluppato da Paul Ekman, massimo esperto di espressioni microfacciali e consulente per il film, le emozioni di base sono sette. Mancano all’appello il Disprezzo e la Sorpresa.
Inside Out è il quindicesimo film della Pixar, in vent’anni di storia della casa. I cinque simpatici omuncoli colorati muovono ogni persona attraverso una bella tastiera, piena di pulsanti, che sembra uscita dalla plancia di comando dell’astronave Enterprise, della serie Star Trek.
Tutto l’armamentario cartesiano, forse inconsapevolmente, viene recuperato e riprodotto. Siamo sempre nell’ombra lunga del filosofo francese; un modello della mente abbastanza datato.
Alla famiglia delle emozioni, come vengono rappresentate nel film, corrisponde la famiglia parentale di Riley, che gioca un ruolo chiave nella vicenda. La famiglia è la prima isola della personalità a formarsi e l’ultima a sgretolarsi. Da essa dipende la vera serenità della bambina. Riley subisce e affronta ogni cambiamento, per uscirne più forte, perché è sostenuta dalla struttura familiare. In questo il film dice una grande verità. Nei primi anni di vita, nella cosiddetta fase evolutiva, la solidità dei legami familiari permette all’individuo di affrontare la realtà e sviluppare una personalità equilibrata.
Quanto al sogno, cartina tornasole di ogni modello della mente, il film lo descrive come uno spazio teatrale nel quale recitano entità mentali, come l’unicorno magico, icona dell’immaginario infantile d’oltreoceano, che realizzano brevi scenette, poi trasmesse al cervello su onnipresenti schermi. È, ancora una volta, il modello cartesiano della percezione e del sogno come teatro, ovvero copia imperfetta del mondo. Viene in mente il quadro di Velasquez sulla favola di Aracne. Anche là, su un palcoscenico pieno di figuranti, la realtà è riprodotta in modo imperfetto.
Il regista non rappresenta la mente, ma l’idea popolare della mente. I ricordi sono simili alle palline di vetro che ancora si trovano in qualche negozio, ognuna con il suo momento congelato, o meglio riprodotto, al suo interno. Palline quasi indistruttibili, che vengono poi accatastate in grandi depositi, dove altri omuncoli, tutti antropomorfizzati, provvedono alla loro archiviazione. Il pensiero astratto è un treno, classica metafora ottocentesca, anch’essa obsoleta. L’inconscio è una prigione buia dove paurosi, ma politicamente corretti, mostri riposano nel sonno della ragione, sia del regista sia degli spettatori.
In tutto il film, apparentemente, comandano sempre i sentimenti; ogni pupazzetto, un sentimento; ma sono sentimenti ed emozioni pensate e sceneggiate in modo fortemente intellettuale.
Nella definizione di questi sentimenti primari si mescolano mitologie antiche non cristiane e non monoteiste, gli dei dell’Olimpo e del politeismo, gli istinti primordiali, gli angeli custodi di più tradizioni e, soprattutto, tecnologicamente, gli incubi di Philip K. Dick e le fantasie di Matrix. Svanisce il libero arbitrio e resta l’idea di una “macchinosa” manipolazione delle nostre azioni.
In Inside Out la narrazione viola, in sostanza, il patto tacito tra sceneggiatori e pubblico: “Parla di me ma non dirmelo mai”. Il rischio è che il film venga percepito non come una rappresentazione scenica, ma come una dinamica reale. «Io funziono davvero così», potrebbe essere l’erronea idea dello spettatore alla fine della proiezione.