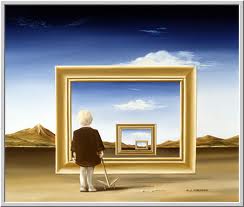
L’inconscio e i filosofi
Molto prima che Freud concepisse un modello della psiche dove la maggior parte dei processi mentali non risultano, direttamente, percepibili alla coscienza, l’idea di inconscio si era, ampiamente, manifestata all’interno del pensiero filosofico. Platone, per primo, attribuì alla mente, nel IX libro della Repubblica, un livello inconscio; mentre nel Menone descrisse in che modo Socrate aveva fatto emergere la “inconscia conoscenza” di un teorema di geometria in un ragazzo privo di istruzione. In epoca meno remota il concetto emerse nel pensiero di Tommaso d’Aquino e da allora divenne sempre più consueto nella filosofia europea. Tuttavia, una effettiva trattazione dell’inconscio inizia solo con Leibniz, quando prende vita una rappresentazione della coscienza che non somiglia a un immutabile e polveroso deposito di contenuti e immagini mentali. Prevale, piuttosto, una idea di coscienza come forma relativa e transitoria, capace però di contenere e rendere oggettivo il mondo. Questa linea, dopo Kant, attraverso il pensiero di Schopenhauer, giunge, nel nostro secolo, fino a Bergson. Essa, in epoca moderna, è fronteggiata, ma non necessariamente contrastata dal patrimonio di conoscenze offerto da quegli studiosi che, fin dall’inizio dell’ottocento, intravidero la presenza e l’importanza di uno psichismo inconscio. Herbart, in particolare, che formulò il concetto di “soglia della coscienza” e Fechner, il capostipite dei contemporanei psicofisiologi che, analizzando le sensazioni fisiche, paragonò la mente ad un iceberg, nascosto, per la maggior parte, all’osservazione immediata. Non a caso, questo paragone fu utilizzato da Sigmund Freud quando propose, per la prima volta nella storia del pensiero, un modello assolutamente “psicologico” dell’inconscio. Tra i maggiori studiosi del rapporto di Freud con la Filosofia va ricordato Paul Laurent Assoun (Freud la filosofia e i filosofi, 1976; Introduzione alla epistemologia freudiana, 1981). Egli approfondisce soprattutto il grande debito contratto da Freud con la filosofia di Schopenhauer. Un debito fondamentale, se si pensa che proprio Schopenhauer fu tra i pochi ad attribuire al sogno quella dignità di oggetto di ricerca che il razionalismo occidentale gli contestava.




