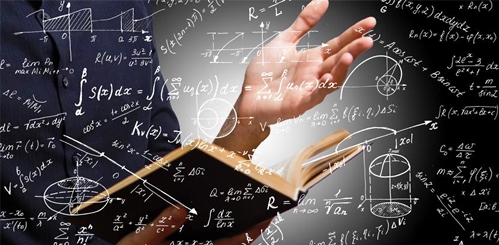
Metodo scientifico e Storia in Psicologia
Quale metodo scientifico di ricerca usare in psicologia? Lo psicologo che si rivolge alle capacità intuitive della sua stessa mente, sembra abolire la scientificità dalla propria ricerca. La psicologia vorrebbe anche un sapere oggettivo, come quello immaginato nel laboratorio di Wilhelm Wundt, alla fine dell’800. Ma l’idea di un sapere universalmente comunicabile si scontra con l’ambivalenza dei fenomeni psicologici studiati. La storia della psicologia descrive i molti tentativi, all’interno di questa disciplina, di produrre un corpo unitario di principi teorici e metodologici. Tali sforzi sono, quasi sempre, naufragati a causa del settarismo metodologico dei ricercatori e dei risultati limitati. E’ quindi un grande insegnamento la riflessione storica sul passato della disciplina.
Nella storia della psicologia del novecento troviamo un panorama a largo raggio sui fondamenti metodologici della materia. La fenomenologia, la psicoanalisi, il comportamentismo, il cognitivismo, la scuola storico culturale e quella biologica. Per ciascuno di questi filoni esistono metodi e territori di ricerca che distinguono una prospettiva dall’altra. Questa coesistenza di prospettive non realizza un corpo unitario di principi teorici e metodologici, ma produce una famiglia di teorie, che si collocano all’interno di una tradizione di ricerca. Diverse e dettagliate formulazioni, in quasi un secolo di storia, hanno determinato, assieme agli errori, occasioni di verità.
In questo panorama psicologico, spesso, lo psicoanalista non comunica con il comportamentista, lo sperimentalista sospetta del fenomenologo e il biologo e il neuroscienziato deridono il sostenitore della prospettiva storico-culturale. E’ necessaria maggiore disponibilità e l’abolizione dei paraocchi scientifici, nella ricerca delle proprie certezze.
Non dimentichiamo quanto siano pedagogiche, ma anche capaci di suscitare compassione, le biografie dei maestri della psicologia. Le inquietudini sentimentali di Brentano, Baldwin e Jung; le depressioni di James, Piaget, Skinner; le sofferenze mentali e fisiche di Freud e Vygotskij; i suicidi di Benussi, Bettelheim, Dunker, Miller, Muchow. Tutte vicende assolutamente umane che, nella loro soggettività, testimoniano quanta distanza possa esistere tra la teoria che si pensa e i sentimenti che si provano.




