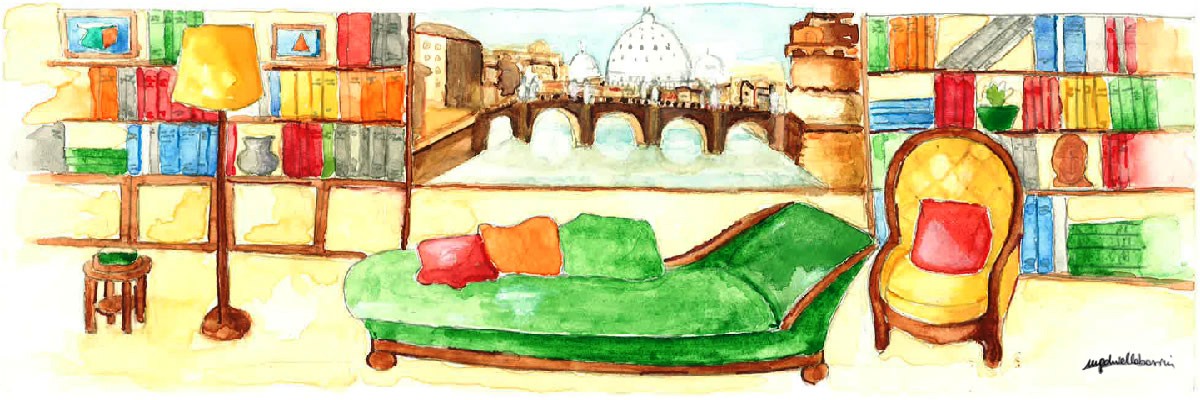
Note storiche sulla prima consultazione psicoanalitica – 2002
Rivista di Pscicoanalisi, 3
La riflessione contemporanea sulla prima consultazione psicoanalitica e sui problemi teorici e tecnici che essa pone, fa riferimento a una lunga e consolidata tradizione nell’ambito della storia della psicoanalisi.
La questione si manifestò, in modo organico, all’inizio degli anni venti, in un contesto fortemente stimolato dagli sviluppi e dai repentini mutamenti sociali e politici dell’Europa post-bellica. Lo stesso Sigmund Freud fu, in una circostanza eccezionale, attratto dall’idea di ampliare le possibilità di contatto tra la psicoanalisi e la società. Ciò accadde nel 1918, subito dopo la prima guerra mondiale, quando i comunisti ungheresi, guidati da Béla Kun, si impadronirono del potere. Fu formata una struttura governativa rivoluzionaria, che avrebbe preso la denominazione di “Governo dei cento giorni”, a causa, appunto, della sua breve durata. Il Ministro della Pubblica Istruzione istituì la prima cattedra di psicoanalisi della storia. Tale insegnamento, che sarebbe durato quanto il governo che lo aveva voluto, fu affidato a Sandor Ferenczi. Quest’ultimo si affrettò ad invitare Sigmund Freud per inaugurare il corso. Nella medesima circostanza si tenne a Budapest il quinto Congresso internazionale di psicoanalisi. Freud intervenne, in questa unica occasione, con un discorso molto attento al problema di una estensione della terapia analitica a più ampi strati della popolazione. “Per il momento -disse- non possiamo fare nulla peri vasti strati popolari che soffrono di nevrosi estremamente gravi… le nevrosi minacciano la salute pubblica non meno della tubercolosi… Dovremo affrontare il compito di adattare la nostra tecnica alle nuove condizioni che si saranno create… Ma quale sia la forma che assumerà la psicoterapia… è sicuro che le sue componenti più efficaci e significative resteranno quelle mutate dalla psicoanalisi rigorosa e aliena da ogni partito preso” (Freud, 1918; tr. it. 1977, pp.27, 28).
La particolarità di questo momento storico, in grado di influenzare la solida compattezza del pensiero di Freud, è alla base della fondazione, nel 1920, del Policlinico psicoanalitico dell’Istituto di Berlino. Storicamente, si tratta della prima struttura, realizzata in occidente, per stabilire un contatto organico tra le istituzioni psicoanalitiche e il mondo sociale.
Per comprendere l’evento, bisogna valutare il contesto culturale e la collocazione in cui il Policlinico psicoanalitico sorse. Dopo la prima Guerra Mondiale, Berlino era divenuta uno dei massimi poli della cultura europea. Nonostante le terribili tensioni sociali, la Germania di Weimar sembrava promettere qualcosa di eccellente e molti gravitavano verso Berlino. La capitale ospitava personalità dello spettacolo come Marlene Dietrich, Greta Garbo e Josephine Baker; mentre il grandioso teatro di Max Reinhard, tre compagnie d’opera e registi come Murnau, Wiene e Pommer, nel fiorire dell’espressionismo, offrivano nuovi modi di rappresentazione a un pubblico ricettivo e interessato. Berlino era divenuto il centro d’Europa. Vi dimoravano scienziati come Einstein e Von Neumann e scrittori come Auden Isherwood. L’arte della Bauhaus prospettava l’idea di un nuovo mondo e proponeva un diverso stato d’animo, un sentimento di libertà che sconfinava nell’euforia.
Purtroppo, la capitale tedesca era anche caratterizzata da situazioni politiche esasperate e da conflitti sociali esplosivi. I quindici anni della Germania di Weimar (1918-33) furono costellati da continui scontri di piazza e da delitti politici, mentre le frequenti crisi economiche stremarono le classi meno abbienti. Nel 1929 la depressione mondiale si abbatteva su un popolo già, duramente, provato. AI peggioramento economico corrispondeva la crescita del movimento nazista.
Il Policlinico psicoanalitico di Berlino fu inaugurato nel 1920; lo dirigevano due pionieri della psicoanalisi: Max Eitingon ed Ernst Simmel, personaggi di indiscussa autorità clinica e molto impegnati in ambito sociale. L’elenco dei partecipanti comprendeva alcuni degli psicoanalisti più importanti di quel periodo: Karl Abraham, Otto Fenichel. Franz Alexander, Paul Federn, Edith Jacobson, Karen Horney e Melanie Klain. Una forte influenza fu anche esercitata da alcuni analisti, ideologicamente vicini al Partito Social Democratico, tra cui: Helene Deutsch, Wilhelm ed Annie Reich, Erich Fromm e Siegfried Bernfeld.
Il Policlinico berlinese rappresentò il primo contributo concreto della psicoanalisi alle trasformazioni della società occidentale; anche se tale iniziativa va considerata, principalmente, per il suo valore storico.
Una caratteristica significativa di questa istituzione fu costituita dall’intento di offrire un servizio di consultazione e terapia psicoanalitica svincolato, al massimo, dalle capacità di pagamento dei vari pazienti. Ciò era possibile, in quanto la struttura fisica dell’istituzione, un grande appartamento al 29 di W.Potsdamer Strasse, era sovvenzionata da alcune donazioni e dalla generosità dei suoi partecipanti che, oltre a svolgere il loro lavoro senza compenso, contribuivano, in più casi, al mantenimento. Questo fu, in primo luogo, l’atteggiamento di Max Eitingon, proveniente da una ricca famiglia galiziana, che si impegnò, con grande generosità, al sostentamento della istituzione che dirigeva e in cui lavorava, senza compenso.
Poiché la questione economica, nel setting analitico, è stata oggetto di attenzione in molti contesti teorici, risulta ancor più interessante la posizione netta che, per primi, assunsero i componenti del Policlinico psicoanalitico di Berlino. Essi sostenevano che l’aspetto del pagamento non avesse una significativa influenza sul corso del trattamento. Gli analisti, quelli in formazione come tutti gli altri, compreso lo stesso Eitingon, trattavano molti pazienti gratuitamente.
Invece, i pazienti che godevano di sufficienti disponibilità economiche venivano invitati a pagare una cifra che, entro certi limiti, variava da caso a caso. Le condizioni in cui si determinava il pagamento erano discusse con il terapeuta e divenivano, esse stesse, oggetto di riflessione analitica.
Lo sfondo teorico lasciava, chiaramente, intendere una progettualità preventiva, rispetto al disagio psichico sociale. Non a caso, il Policlinico di Berlino fu la prima istituzione psicoanalitica in cui si concretizzò l’attenzione e la ricerca nel campo della psicoanalisi infantile, poiché diversi bambini, provenienti da ceti sociali disagiati, giungevano all’esame degli analisti.
Fin dalla inaugurazione, i promotori del Policlinico si posero il problema della “visibilità”, ovvero di far conoscere, concretamente, agli utenti l’esistenza di questa possibilità terapeutica. Si tratta di una questione di estrema attualità. I centri di prima consultazione contemporanei devono confrontarsi con lo stesso problema. E’ necessario promuovere la visibilità attraverso una opera di diffusione della notizia che consenta 1’arrivo dei pazienti nei centri di consultazione; ma quest’opera di visibilità deve essere realizzata senza danneggiare l’immagine sociale e l’identità scientifica della psicoanalisi. D’altra parte, poiché tali caratteristiche sono, ovviamente, oggetto di dibattito e, storicamente, relative, le controversie sull’argomento determinano, facilmente, un tendenziale immobilismo nell’attività di promozione. Nella situazione italiana, se si eccettua qualche depliant, i maggiori strumenti di visibilità dei centri di consultazione psicoanalitica sono il passaparola e l’elenco telefonico.
Ecco, come testimonianza storica, il modo in cui si confrontarono con il problema i promotori del Policlinico berlinese. Tutti i giornali del luogo furono informati che l’istituzione avrebbe aperto l’attività il giorno 16 febbraio 1920, al numero 29 di W.Potsdamer Strasse e la notizia fu, puntualmente, divulgata. Inoltre, l’intera giornata del 24 febbraio 1920 fu dedicata ad una pubblica inaugurazione, durante la quale i membri e gli amici dell’Associazione eseguirono brani di musica classica e lessero versi poetici. Lo stesso Ernst Simmel declamò un brano di Reiner Maria Rilke, mentre Karl Abraham concluse la manifestazione con un discorso intitolato: “Il riemergere del Policlinico dall’inconscio”. Non si può dimenticare che i complessi problemi legati alla specificità della psicoanalisi ed alla necessità di un adeguato setting dovevano, ancora, essere pienamente formalizzati ed entrare a far parte del dibattito scientifico collettivo. Il Policlinico psicoanalitico di Berlino è stata la prima situazione collettiva in cui la psicoanalisi ha avuto modo di confrontarsi con le trasformazioni del mondo sociale, valorizzando gli effetti di un proprio impegno concreto.
Il problema del pagamento fu solo un elemento, per altro teoricamente limitato, tra i vari aspetti di rilevanza sociale presi in considerazione. In questa istituzione, tra le prime, ci si occupò, attivamente, di psicoanalisi infantile. Anche per acquisire spazi più ampi e più adatti al trattamento dei bambini il Policlinico, nel 1928, si trasferì al numero 10 di Wichmannstrasse (Cfr. Danto; 1999). Ciò aveva l’intento di ampliare e consolidare un modello teorico di intervento psicoanalitico, strettamente connesso al concetto di prevenzione sociale. Questa idea, storicamente, proveniva dal movimento psicoanalitico russo che, mentre in quel periodo si andava estinguendo, a causa della intolleranza ideologica del regime staliniano, aveva, pochi anni prima, conosciuto una ricca fioritura. (Cfr. Angelini, 1988). Sempre in questo contesto appare, per la prima volta, l’interesse per una applicazione dei metodi statistici al trattamento psicoanalitico.
Il principale fautore di questa iniziativa sperimentale fu Otto Fenichel, affiancato da Karen Horney e, in seguito, da altri analisti. Furono realizzate, per diversi anni, delle tavole statistiche contenenti i dati dei pazienti e le indicazioni dei trattamenti. Nell’arco di dieci anni, dal 1920 al 1930, furono effettuate 1955 consultazioni; 969 erano uomini, 986 erano donne. I pazienti provenivano dalle più diverse classi sociali e appartenevano a tutte le fasce d’età, compresi molti bambini. Ciò in un periodo in cui la psicoanalisi si rivolgeva, essenzialmente, agli adulti. Tutte le categorie cliniche venivano considerate e classificate. L’interesse di Fenichel per le statistiche e la sua nota capacità nell’organizzare tabelle e compendi (Cfr. Angelini, 1996) giocò un ruolo fondamentale nella realizzazione di questi lavori. Comunque, la maggiore attenzione era riservata alla presa in esame degli aspetti qualitativi dell’analisi, con particolare riferimento alla motivazione ed ai criteri di analizzabilità. L’ammissione al trattamento e la sua urgenza erano decise dall’analista incaricato del primo colloquio, in base, prima di tutto, alla gravità del problema constatato e, secondariamente, valutando la motivazione manifestata dal paziente. Nel contesto del Policlinico psicoanalitico di Berlino vennero anche discusse, per la prima volta, le caratteristiche del setting in una situazione istituzionale. Molti problemi, sia di carattere pratico, sia di carattere concettuale, portavano a riflettere sulle modalità di svolgimento dei colloqui con i pazienti. Questa attenzione rievocava alcune delle idee espresse da Sandor Ferenczi, fin dal 1918, a Budapest, durante il quinto Congresso della Associazione Psicoanalitica Internazionale. Nell’ambito del Policlinico berlinese si dibatté la possibilità di abbreviare o accelerare il trattamento terapeutico, di variare i sessanta minuti di durata della seduta, di coinvolgere il paziente in alcune decisioni relative al trattamento e così via. Controversie pratiche ed etiche che avrebbero interessato, in più occasioni e in varie epoche, diversi esponenti del movimento psicoanalitico.
Il Policlinico era aperto dalle 8 del mattino alle 20 di sera, quotidianamente. L’età dei pazienti andava da sotto i cinque anni a sopra i sessanta, anche se per la maggioranza erano giovani adulti. Nei dieci anni di attività, su 1955 colloqui effettuati, furono portate a compimento 721 analisi. Gli altri interventi riguardarono psicoterapie e consulenze. I pazienti provenivano da tutte le classi sociali, sebbene in modo non omogeneo.
Secondo Otto Fenichel. che tentò, cautamente, di individuare dei criteri diagnostici, ricorrevano, con maggior frequenza, dei problemi di carattere isterico. Al secondo posto si trovavano le nevrosi ossessive, mentre alcune diagnosi fisiologiche, come l’epilessia e l’asma, si incrociavano con categorie psicopatologiche che includevano la depressione, la mania e la paranoia. In questo contesto emerse, anche, il problema dei pazienti gravi, portatori di severe psicosi, che non riuscivano a rapportarsi con la situazione ambulatoriale offerta dal Policlinico psicoanalitico. Da questa difficoltà, molto probabilmente, nacque l’idea, realizzata da Ernst Simmel, di aprire una clinica psicoanalitica per pazienti gravi.
Il sanatorio “Schloss Tegel” iniziò la sua attività nel 1927; qui Simmel tentò di applicare i criteri della psicoanalisi alla cura delle psicosi. Freud apprezzò molto l’iniziativa e, negli anni seguenti, quando dovette recarsi a Berlino, soggiornò diverse volte nella clinica, a mezz’ora dalla città, immersa in un parco, vicino al lago Tegel (Cfr. Jones, 1953; tr. it. 1962, v. III).
L’attività della clinica “Schloss Tegel” era, strettamente, collegata con quella del Policlinico psicoanalitico di Berlino. Da quest’ultima istituzione provenivano diversi dei pazienti accolti da Simmel. Anche in questo caso, si tentava, al massimo, di evitare che la cura psicoanalitica fosse condizionata da limiti economici. Del resto, Ernst Simmel era di convinzioni socialiste. Assieme a Max Eitingon era ispirato, oltre che dal rigore scientifico, da valori di solidarietà e sociali. I responsabili del Policlinico berlinese e molti dei collaboratori si consideravano intellettuali di ispirazione umanitaria e cosmopolita. La psicoanalisi era concepita non solo come una terapia, ma come una forza culturale, parte di un progetto complessivo. Avevano scelto la psicoanalisi con il proposito romantico di cambiare il mondo.
Purtroppo, con il mutare del clima politico di Weimar e con l’avanzata del nazismo, l’istituzione berlinese andò incontro a un destino negativo.
Agli inizi del 1933, poco dopo il consolidamento del nazismo, i lavori di Freud vennero messi all’indice, Simmel fu arrestato ed Eitingon emigrò in Palestina.
Nel 1936, il locale in cui era ospitato il Policlinico psicoanalitico fu acquisito dall’Istituto Germanico per la Ricerca Psicologica e la Psicoterapia, diretto da Mattias Heinrich Goring, cugino di Hermann Goring.
Nonostante ciò, il Policlinico psicoanalitico di Berlino esiste tuttoggi; è sopravvissuto al nazismo, alla guerra, alle controversie di mezzo secolo e rappresenta un punto di riferimento storico e teorico.
Hanno scritto Thomä e Kächele: “C’è ancora la situazione del vecchio Istituto psicoanalitico di Berlino, fondato con mezzi privati da Eitingon. che permetteva ai pazienti con scarse possibilità economiche di essere trattati quasi gratuitamente” (1985; tr. it. 1990, vol. I, p. 278).
Il Policlinico berlinese, fin dagli esordi, attirò l’attenzione del movimento psicoanalitico internazionale. I membri della Società di Vienna, toccati nell’orgoglio, vollero emulare i tedeschi. Nonostante la feroce resistenza del mondo psichiatrico ufficiale, un Centro viennese di consultazione clinica fu aperto nel 1922, con il nome di “Ambulatorium”.
D’altra parte, in quello stesso periodo, in Russia, dove il movimento psicoanalitico era assai fecondo, la questione veniva affrontata in modo autonomo, conformemente alla situazione storica determinatasi a seguito della rivoluzione d’ottobre. Tatiana Rosenthal, che avrebbe poi fondato, nel 1921, con Alexander Luria, Lev Vygotskij ed altri la Società Psicoanalitica di Mosca, diede vita, fin dal 1919, ad una clinica psicoanalitica nel neonato “Istituto di Ricerche sulla Patologia del Cervello” di Pietroburgo. L’istituzione era pubblica, gestiva diversi ambulatori e i trattamenti, sulle cui modalità disponiamo, però, di scarse informazioni, erano gratuiti. Altrettanto gratuita fu, in seguito, l’ammissione dei bambini accettati dall’Asilo Psicoanalitico di Mosca. Il costo del piccolo istituto era sostenuto, essenzialmente, da contributi delle organizzazioni sindacali.
In Gran Bretagna, nel 1926, venne fondata la clinica psicoanalitica di Londra, per pazienti con difficoltà economiche. Il suo primo direttore fu John Rickman che, peraltro, aveva organizzato servizi medici in Russia ed era anche responsabile, assieme ad Ernest Jones. dell’attività editoriale dell’Istituto di psicoanalisi britannico, costituitosi nel 1924.
Dopo la seconda guerra mondiale, la tematica della prima consultazione psicoanalitica emerse, in varie situazioni, nel movimento psicoanalitico internazionale. Ciò accadde sia perché essa proponeva la questione del rapporto tra psicoanalisi, istituzioni e mondo sociale, sia perché, nella prima consultazione psicoanalitica, convergevano diverse, rilevanti questioni cliniche e teoriche.
Non appartiene all’ambito di questo lavoro, il compito di una disamina particolareggiata delle differenti iniziative. E’ opportuno, comunque, ricordare che, già negli anni cinquanta, iniziarono a costituirsi, negli Stati Uniti, cliniche a orientamento psicoanalitico legate sia all’iniziativa dei singoli, sia a momenti istituzionali. Fu molto sentita, in questo contesto l’attenzione al concetto di analizzabilità. Infatti, come ha scritto Ruben Fine: “Alla fine della prima guerra mondiale, la psicoanalisi era già divenuta una procedura lunga e costosa” (1979; tr. it. 1982, p. 339). Quindi era ovvio che gli analisti cercassero, dall’inizio, dei criteri per determinare se un dato paziente fosse in grado di seguire l’intero processo, ossia se fosse o meno analizzabile. Valga come esempio la ricerca svolta da Lower, Escoll e Hunter nella clinica psicoanalitica di Filadelfia, collegata all’omonimo Istituto e pubblicata nel 1972.
Anche in Argentina, negli anni settanta, fu fondata una clinica psicoanalitica, intitolata al “Dott. Enrique Racker”, dove i candidati potevano svolgere un tirocinio pratico e dei primi colloqui.
L’attenzione al concetto di analizzabilità è sempre stata una caratteristica dei centri di consultazione psicoanalitica, fin dalla loro prima comparsa e trae origine da un problema caratteristico della “Età d’oro” della psicoanalisi.
Negli anni venti, presso l’Istituto Psicoanalitico di Berlino, la domanda di psicoanalisi superava, di molto, l’offerta. Ciò rese necessario un impegnativo processo di selezione.
Riferisce Fenichel, nel 1930, che oltre ai criteri d’indicazione della terapia psicoanalitica, si tenevano presenti, per l’accettazione, due disposizioni dell’Istituto: il caso doveva prestarsi alla ricerca scientifica e all’insegnamento. Il rapporto tra il numero delle consultazioni e il numero dei trattamenti iniziati era, allora, di circa 2,5:1. Tuttavia si constatava un alto numero di analisi interrotte, dopo breve tempo. Inizialmente, per fronteggiare questo fenomeno fu adottato il criterio della “analisi di prova”. Le numerose difficoltà che si manifestarono, con l’applicazione di questo metodo, spostarono il problema di una corretta indicazione alla psicoanalisi dalla “analisi di prova” al primo colloquio.
Per Thomä e Kächele: “I problemi che dovevano essere risolti durante la prima intervista nell’ambulatorio del vecchio Istituto psicoanalitico di Berlino sono gli stessi che ancora oggi devono essere risolti in tutti gli ambulatori clinici istituzionali; l’attività psicoanalitica privata ne è meno interessata, perciò la maggior parte delle pubblicazioni relative alla prima intervista provengono dalle esperienze degli analisti nelle istituzioni pubbliche. Inoltre, solo in pochi istituti di formazione psicoanalitica si insegna espressamente la tecnica del colloquio” (1985; tr. it. 1990, p. 234).
Con qualche differenza, questo appare il contesto contemporaneo del lavoro della prima consultazione.
La letteratura scientifica sulla prima consultazione e sulla intervista, in genere, si è ampliata in modo sostanziale.
Prescindendo, qui, da una bibliografia generale, valga per tutti l’esempio di un autore importante come Kenberg (1977, tr. it. 1987 e 1981), che si è dedicato, in più occasioni, all’argomento.
La prima consultazione psicoanalitica offre numerosi elementi di riflessione, sia in campo clinico e scientifico, sia in ambito istituzionale. Merita la crescente attenzione che sta attirando negli ultimi anni.
SINTESI
La storia della prima consultazione psicoanalitica inizia nel 1920, con la fondazione del Policlinico psicoanalitico dell’Istituto di Berlino. Lo dirigevano due pionieri della psicoanalisi: Max Eitingon ed Ernst Simmel. Parteciparono all’impresa gli psicoanalisti più importanti di quel periodo. L’istituzione sopravvisse al nazismo e alla guerra, ispirando analoghe iniziative in altri paesi e in altri tempi.
BIBLIOGRAFIA
Angelini A., La psicoanalisi in Russia, Liguori, Napoli, 1988.
(2) Angelini A., Otto Fenichel: psicoanalisi, politica e società, Cosmopoli, Bologna, 1996.
(3) Danto E. A., The Berlin Poliklinik: psychoanalytic innovation in Weimar Germany, in: Journal of the American Psychoanalytic Association, 4/1999, pp. 1269-1292.
(4) Fenichel O., Statisticher Bericht uber die therapeutische Tatigkeit 1920-1930, in: Radò S., Fenichel O., Muller-Braunschweig C. (Hrsg), Zehn Jahre Psychoanalytisches Institut. Poliklinik und Lehranstalt. International Psychoanalitic Verlag, Wien, 1930.
(5) Fine R., A History of Psychoanalysis, 1979; tr. it. Storia della psicoanalisi, Boringhieri, Torino, 1982, p. 339.
(6) Freud S., Wege der psychoanalityschen Therapie, 1918; tr. it. Vie della terapia psicoanalitica, in Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino, 1977, pp. 27, 28.
(7) Jones E., The Life and Work of Sigmund Freud, 1953, tr. it. Vita e opere di Freud, (III), Il Saggiatore, Milano, 1962.
(8) Cfr. Kernberg O.F. The structural diagnosis of borderline personality organization. In: Hartocollis P. (ed.), Borderline personality disorders. Int. Univ. Press, New York, 1977, pp. 87-121; tr. it. “Il colloquio diagnostico strutturale”, in : Disturbi gravi della personalità, Bollati Boringhieri, Torino, 1987.
Structural interviewing. In: Psychiatr. Clin. North Amer., 4/1981, pp. 169-195.
(9) Lower R.B., Escoll P.J. and Huxter H.K., Bases for Judgments of Analyzability, 1972, in: Journal of the American Psychoanalytic Association; 20, pp. 610-621.
(10) Thomä H. e Kächele H., Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie, 1° Grundlagen, 1985; tr. it. Trattato di Terapia psicoanalitica, 1°: Fondamenti teorici, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, p. 278.
(11) Thomä H. e Kächele H., Op. cit. 1985; tr. it. 1990, p.234.




