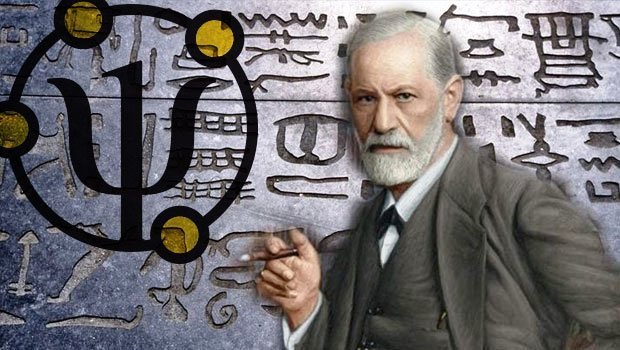
Psicoanalisi e istituzioni pubbliche
Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, disciplina che studia i processi non consapevoli della psiche, per primo, mise in evidenza i possibili punti di attrito tra le conoscenze psicoanalitiche e il mondo delle istituzioni sociali; ovvero il mondo concreto degli ospedali psichiatrici e degli ambulatori. A distanza di circa un secolo, questi conflitti non sono scomparsi, anche se la loro presenza assume i toni più svariati, in perfetta sincronia col mutare delle mode e delle ideologie. L’aspirazione a utilizzare la psicoanalisi nelle istituzioni pubbliche, ospedaliere e ambulatoriali, non è nuova. A questo ambizioso progetto si sono sempre opposte difficoltà concrete. Come conciliare, per esempio, i ritmi di lavoro di uno psicoanalista, che incontra un paziente ogni ora in un ambiente tranquillo, con le esigenze da prima linea di una pubblica istituzione preposta alla salute mentale? Come fronteggiare i relativi costi? Nonostante la difficoltà, da diversi anni un gruppetto entusiasta di psicoanalisti e psichiatri sta percorrendo questa strada. Tempo fa, Massimo Ammaniti, professore di psicopatologia nell’università di Roma e membro della Società Psicoanalitica Italiana, sostenne la positività di questo orientamento. Anche se non si realizza una vera e propria terapia psicoanalitica nelle situazioni istituzionali, la psicoanalisi fornisce un modello di lavoro e di comprensione. D’altra parte, non solo non è un modello adeguato alla burocrazia, ma ha il potere di contentare la stessa struttura in cui opera, rendendo difficile la sua accettazione? A contenere questo inevitabile conflitto tra la conoscenza psicoanalitica e i bunker corazzati della burocrazie istituzionale si adoperano tutti coloro che vogliono favorire l’incontro fra le due. In realtà. Il potere conflittuale della psicoanalisi non riguarda semplicemente le istituzioni sanitarie. Le interpretazioni psicoanalitiche, hanno attraversato, fin dagli esordi, le mura silenziose degli studi di psicoanalisi pe addentrarsi, al massimo, nella comprensione dell’intera società umana.
La psicoanalisi non finisce la dive iniziamo la politica, la sociologia, la religione o l’arte. Poiché è uno strumento di comprensione dell’uomo, si addentra in tutte le attività umane. Anche se sarebbe un errore pretendere di interpretare la storia umana attraverso le sola psicoanalisi, sarebbe altrettanto errato inseguire una comprensione dei fenomeni umani escludendo completamente l’interpretazione psicoanalitica. Nella ricerca di questo delicato equilibrio teorico, è facile turbare i sonni millenari con cui le più diverse istituzioni sociali reagiscono al mutare dei tempi e ai bisogni dell’individuo. L’analisi dell’inconscio porta sempre alla luce desideri che contrastano con le regole morali e civili della convivenza umana. Questo conflitto non ha soluzioni definitive; richiederebbe, invece, continui adeguamenti, sia da parte dell’individuo che della società. L’illusione di un equilibrio immutabile tra il singolo e le istituzioni è una chimera che, se aiuta a placare l’ansia di chi teme i cambiamenti, non rispecchia la realtà dei fatti. Effettivamente, in una società dove vanno di moda, per esempio, le cadute dei governi e i quattrini sopra tutto, non è facile orientarsi verso l’inconscio senza sperimentare, come minimo, un vago disagio all’idea di ciò che si potrebbe incontrare. Fortunatamente, le istituzioni sociali, soprattutto quelle scientifiche provvedono, continuamente, a produrre smisurate quantità di polistirolo ideologico, essenziale per attutire l’urto dei crani con la dura realtà dell’inconscio. Per questo motivo la maggior parte delle psicoterapie che sono succedute alla psicoanalisi si sono concentrate sulla cura clinica del paziente, trascurando le istanze inconsce della mente umana. Si sta attuando, nella stessa psicologia, vista come istituzione sociale, un fenomenale meccanismo di rimozione che cerca di equiparare, anche sul piano storico e giuridico l’enorme potenziale conoscitivo della teoria psicoanalitica alle più diverse e povere trovate di sapore psicoterapeutico. A ciò si aggiunga che la cultura italiana contemporanea, anch’essa istituzionalizzata in forme pubbliche e private, è stata a lungo perseguitata dalla moda del cosiddetto “pensiero debole”, che rifiuta le grandi teorie conoscitive preferendo riflessioni limitate. E’ ovvio che in questo festival della debolezza, una teoria forte e capace di vaste interpretazioni, come quella psicoanalitica, trova opposizione.




