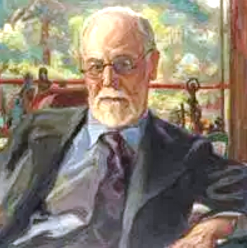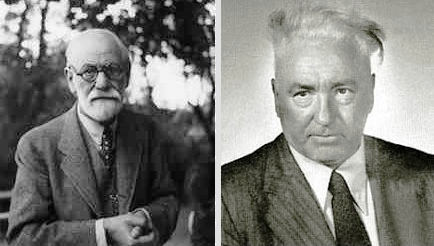
Sulle dieci lettere di Sigmund Freud a Wilhem Reich (1924-1930) – 2013
Rivista di Psicoanalisi, 1
SULLE DIECI LETTERE DA SIGMUND FREUD
A WILHELM REICH (1924 – 1930)
Alberto Angelini
Delle lettere che Sigmund Freud scrisse a Wilhelm Reich, tra il 1924 e il 1930, non conosciamo gli antefatti. Si tratta di risposte a messaggi di vario tema che Reich inviò al Maestro. Così ci sono giunte, dopo essere state conservate, per quasi un secolo, nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, all’interno degli Archivi Sigmund Freud, di cui è, attualmente, curatore Harold Blum, succeduto a Kurt Eissler. Tuttavia, ancor prima di addentrarsi in una riflessione storica, è sufficiente leggere le parole del fondatore della psicoanalisi per comprendere il tipo di argomenti che il giovane Reich gli sottoponeva. Si tratta, in buona parte, di valutazioni e giudizi, relativi ad un vasto numero di articoli, saggi, programmi di studio, linee di ricerca e bozze di idee che Reich proponeva al giudizio di Freud. In quegli anni, infatti, il giovane Reich scriveva e pubblicava lavori ad un ritmo vertiginoso. Ciò è testimoniato, prima di tutto, dalla vasta raccolta degli Scritti giovanili (1920-1925). Valgano, inoltre, come esempi più rilevanti, tra i suoi molti saggi di quel periodo, Il coito e i sessi (1922), Il tic psicogeno come equivalente della masturbazione (1925), il volume La funzione dell’orgasmo (1927) e il saggio di argomento metodologico Materialismo dialettico e psicoanalisi (1929). A questa ricca produzione saggistica, si aggiungeva una turbinosa attività personale, sia in ambito clinico, sia in campo istituzionale, all’interno della Società Psicoanalitica Viennese. Come si potrà evidenziare dalle lettere qui pubblicate, Freud si esprimeva con cautela riguardo al pensiero del giovane allievo, pur confortandone gli slanci giovanili.
Accanto a questi temi plausibilmente scientifici, emergono, dalle parole di Freud, vari indizi riguardo alle dinamiche interne dell’istituzione psicoanalitica, in cui Reich era coinvolto. Nel 1922 quest’ultimo era stato nominato assistente, nella Clinica Psicoanalitica appena costituita dallo stesso Freud e, nel 1924, era divenuto direttore del Seminario Tecnico Psicoanalitico. In virtù di questo incarico, fino al 1930, avrebbe insegnato nell’Istituto del Training Psicoanalitico, sempre a Vienna.
A questi stessi anni corrisponde la datazione delle lettere. Da esse trapelano, anche, le progressive difficoltà relazionali e istituzionali a cui Reich andò incontro, a causa delle sue idee e della sua personalità. Del resto, questa conflittualità con l’ambiente esterno, in ogni circostanza, fu una caratteristica di tutta la sua vita.
Nel periodo in cui si svolse la corrispondenza che stiamo esaminando, Wilhelm Reich era profondamente impegnato nell’elaborazione di una teoria che collegasse ed armonizzasse, in una singola proposta concettuale, la visione storica e sociale del marxismo con le innovative concezioni psicoanalitiche riguardanti la mente individuale. In ciò risultava, profondamente, influenzato dalle nuove idee, in ambito psicologico, storico e culturale, che la rivoluzione russa del 1917 andava proiettando, in quegli anni, in tutta Europa.
Esisteva, allora, un forte conflitto tra le idee dei teorici del marxismo sovietici ed i marxisti europei ed austriaci. In questo dibattito si inserì Reich, con vari interventi e, soprattutto, con il saggio Materialismo dialettico e psicoanalisi (1929), scritto nel periodo del suo massimo impegno, come psicoanalista, a Vienna. Il dibattito che contrapponeva i marxisti sovietici a quelli europei ruotava intorno all’importanza da dare al “fattore umano soggettivo” nello sviluppo economico e storico della società. Senza entrare nei dettagli di una controversia filosofica complessa e ormai storica, è comunque opportuno, in questo ambito, delineare i concetti trattati, per dare un significato al grande coinvolgimento di Reich nella questione. In sostanza, i sovietici ed, in particolare A. M. Deborin (1924) e V. Jurinetz (1925), con cui Reich avrebbe polemizzato, cercavano di limitare e sminuire l’importanza del fattore umano soggettivo nella storia. L’individuo non aveva potere rispetto ai grandi processi storici ed economici della società umana. Essi si verificavano, in un certo senso automaticamente, per leggi intrinseche alla dialettica storica del mondo sociale. In questa prospettiva, si sarebbe, in seguito, posto anche I. Sapir (1929-30), replicando direttamente alle idee espresse da Reich in Materialismo dialettico e psicoanalisi (1929). Per l’ideologia sovietica dominante, non c’era possibilità di incontro tra il materialismo storico e la psicoanalisi. Peraltro, anche un personaggio come V.N. Volosinov (1927), firma dietro cui si nascondeva l’opera del grande semiologo russo M. M. Bachtin, considerava l’inconscio un concetto utile, unicamente, per spiegare i disturbi mentali individuali e non come una forza operante a livello sociale. Deborin e Jurinetz erano, paradossalmente, l’ala più moderata di questa corrente meccanicista sovietica che, nell’arco di pochi anni, avrebbe addirittura fatto scomparire il nome di Freud dalle riviste specializzate e cristallizzato l’intera psicologia russa, per quasi mezzo secolo (Cfr. Angelini, 1988, cap. X).
A questa interpretazione meccanica del materialismo storico marxista si contrapponevano, in Austria, personalità come K. Korsch (1923) e M. Adler (1925).
Contemporaneamente, un grande filosofo come György Lukács (1923), sebbene la problematica psichica individuale fosse sempre estranea al suo ambito teorico,
veniva attirato dal dibattito sulla “dereificazione” della società, attuata tramite lo smascheramento dell’immutabilità delle leggi sociali. Il tema discusso era quale posto avesse la soggettività umana nella storia.
D’altra parte, in quegli anni, la psicoanalisi aveva fortemente attecchito nell’ambito della società e della cultura russe (Angelini, 2002). Dopo la rivoluzione d’Ottobre, in Unione Sovietica, la psicoanalisi visse, per pochi anni, un periodo fulgido. Riprese vitalità la Società Psicoanalitica di Mosca, che aveva cominciato a riunirsi, a partire dal 1911 e una seconda Società Psicoanalitica fu fondata a Kazan da Alexander R.
Luria. Un nutrito gruppo di giovani entusiasti partecipò all’affermarsi del pensiero psicoanalitico, in Russia. Tra questi: V. Schmidt, S. Spilrein, P.P. Blonskij, M.A. Rejsner, B.E. Bychovskij, B.D. Fridman, A.B. Zalkind ed altri (Angelini, 2008). Alcuni di costoro, come Luria, pubblicavano anche su riviste occidentali e in lingua tedesca. Perfino la grande personalità di Lev S.Vygotskij, il fondatore della scuola psicologica “storico culturale”, fu coinvolta dalla psicoanalisi. Nel 1925, Vygotskij e Luria, entrambi allora partecipanti alle riunioni della Società Psicoanalitica Moscovita, scrissero l’introduzione della traduzione russa del lavoro di Freud Al di là del principio del piacere (1920). Sempre nel 1925, K.N. Kornilov curò una raccolta di saggi, dal titolo Psicologia e marxismo, dove più autori, tra cui Luria, affrontarono i problemi metodologici della psicoanalisi, nella prospettiva filosofica e sociologica. Queste idee, generate dall’ambito scientifico e culturale sovietico circolavano, su varie riviste e in virtù di traduzioni, in tutto l’ambiente della sinistra europea.
Wilhelm Reich, proprio nel periodo in cui corrispondeva con Freud, ne risulta, profondamente, influenzato. In particolare, egli risulta portatore di un debito di gratitudine con i pensieri espressi da Alexander Luria in tre scritti successivi: La psicoanalisi come sistema di psicologia monista (1925), La moderna fisiologia russa e la psicoanalisi (1926) e Die moderne Psychologie und der dialektische Materialismus (1928). L’articolo del 1926, di Luria, fu pubblicato sull’Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, che Reich leggeva, in quanto psicoanalista. L’altro articolo di Luria, del 1928, fu pubblicato sulla rivista Unter dem Banner des Marxismus, che era la versione tedesca di una omonima rivista russa ed era considerato l’organo ufficiale degli intellettuali comunisti di lingua tedesca. Al partito comunista austriaco, Reich si era iscritto fin dal 1927. Non a caso, la principale opera metodologica di Reich di quel periodo, Materialismo dialettico e psicoanalisi (1929), fu pubblicata proprio su Unter dem banner des Marxismus. Molte delle idee proposte da Reich in Materialismo dialettico e psicoanalisi riecheggiano i concetti avanzati da Luria, nei suoi articoli degli anni precedenti. In particolare, Luria (1925), assumendo un atteggiamento favorevole verso la psicoanalisi, aveva ribadito la causalità biologica delle pulsioni e, nell’indagare sulle “fonti organiche” delle medesime, era entrato nel merito di quel modello “tensione – scarica” che Reich, nel 1927, avrebbe messo alla base delle sue elaborazioni ne La funzione dell’orgasmo. Ovviamente, non si vuole affiancare l’eterogenea opera di Reich alle concezioni generali di Alexander Luria, fondatore della contemporanea neuropsicologia, ma solo evidenziare alcuni, significativi, punti di contatto. Ciò anche per non svalutare l’originalità del pensiero espresso da Reich, che dimostrò, in quell’ambito temporale, una autonoma organizzazione.
Quel che, piuttosto, risulta evidente, spostandosi dalla biografia alla dimensione storica, è l’incompatibilità di queste concezioni con le prospettive teoriche sostenute, allora, da Freud per la psicoanalisi, sia sul versante clinico, sia su quello istituzionale. Se, come risulta da una prospettiva indiziaria, Reich sottopose i suoi scritti metodologici, impregnati di marxismo, a Freud, l’accoglienza non fu favorevole e diversi passaggi della loro corrispondenza lo suggeriscono.
Nei fatti, l’atteggiamento di Freud e dell’ambiente psicoanalitico di Vienna fu, progressivamente, sempre più ambivalente nei confronti del giovane Reich. Egli era stimato per le sue capacità tecniche ed organizzative ma, contemporaneamente, la sua estrema passione politica imbarazzava ed allarmava il mondo quieto della psicoanalisi viennese. Inoltre, anche sul piano clinico, proprio negli anni della corrispondenza con Freud, Reich andava sviluppando delle idee che si discostavano molto dal pensiero del suo maestro.
Ciò emerge, primariamente, ne La funzione dell’orgasmo (1927). Ha scritto Robinson
(1969, 17): “Tutto lo sviluppo intellettuale di Reich potrebbe essere definito un’elaborazione del concetto freudiano di libido”. Effettivamente l’intera produzione reichiana non abbandona mai l’esigenza di attribuire una quantità, in senso filosofico, cioè un’estensione ed una divisibilità, alla libido. Reich desiderava, letteralmente, osservare e misurare la libido. Nel perseguire questo intento finì per sovrapporre e far coincidere la nozione di libido con quella di sessualità. Peraltro anche il primo Freud emergeva dall’ambiente del riduzionismo biologico ottocentesco e, nel 1910, aveva anch’egli avuto un innamoramento fisicalista, accostandosi alla dottrina “energetista” del chimico-fisico e filosofo Wilhelm Ostwald (1853-1932), che lo aveva invitato ad una collaborazione sulla sua rivista Annalen für Naturphilosophie (Angelini, 1985).
Negli anni tra il 1924 e il 1930, quando Freud in una età matura della vita scrive, tra l’altro, Inibizione sintomo e angoscia (1925), L’avvenire di una illusione (1927) e Il disagio delle civiltà (1929), Reich si lancia, a testa bassa, nel tentativo di dimostrare che tutti i disturbi nevrotici, senza esclusione, si accompagnano a turbe dell’attività sessuale. Anche secondo una valutazione superficiale degli interessi di Freud, in quel periodo, appare evidente come tra le strade percorse dal maestro e dall’allievo esistessero significative differenze di orientamento. Reich, comunque, pretese sempre di essere fedele alla primitiva idea freudiana dello “accumulo” e della “scarica”, esposta nel Progetto per una psicologia (1895).
La riflessione ruotava intorno ai concetti freudiani di psiconevrosi e di nevrosi attuale. Col termine psiconevrosi Freud intende caratterizzare quelle affezioni psichiche in cui i sintomi si presentano come espressione simbolica dei conflitti infantili, in particolare le nevrosi da transfert e le nevrosi narcisistiche (Freud 1894, 1896, 1898, 1915-17). Questo termine viene da lui utilizzato, essenzialmente, in contrapposizione a quello di nevrosi attuale (Freud 1898, 1912, 1915-17), in cui l’eziologia è invece ricercata in una disfunzione somatica della funzione sessuale. Lo stesso Freud e, in seguito Ernest Jones, non mancarono di indicare la correlazione clinica fra le due formazioni (Angelini, 1984). Reich aggredisce questa correlazione con l’intento di dimostrare che qualsiasi tipo di sintomo psiconevrotico deve avere alle spalle un fonte energetica che lo alimenta e individua questa fonte nella sessualità. L’ambiente psicoanalitico viennese, oltre allo stesso Freud, avvertiva in queste teorie una svalutazione della prospettiva simbolica.
A onor del vero, questa impostazione reichiana, accettando la nozione freudiana di regressione pregenitale, non contestava la valenza simbolica dei sintomi nevrotici, né identificava, riduttivamente, le psiconevrosi con le nevrosi attuali. Reich si concentrava sugli aspetti quantitativi di queste due formazioni perché sperava, con questo percorso teorico, di mantenere la psicoanalisi coerente con le concezioni filosofiche del materialismo dialettico marxista. Tutta la sua attività, pratica e teorica, era, allora, condizionata dall’impegno politico e vedeva, nell’incontro fra il marxismo e la psicoanalisi, una potente opportunità di progresso per entrambe le dottrine.
Come si può immaginare, il cauto ambiente psicoanalitico viennese iniziò, progressivamente, a percepire Wilhelm Reich come un corpo estraneo. Lo stesso Paul Federn, suggerì, nel 1928, di togliere Reich dalla direzione del Seminario Tecnico Psicoanalitico. Resistevano alcune amicizie personali; in particolare quella con Otto Fenichel, ma la sua attività politica intimoriva i colleghi non apertamente schierati sulle posizioni della sinistra.
Per di più, nel 1928 aveva fondato l’Organizzazione Socialista per la Ricerca e la Consulenza Sessuali che lo avrebbe impegnato prima a Vienna e poi, dal 1930 a
Berlino, con la denominazione di Sexpol, in una intensa attività di consultazioni e seminari. In effetti, Reich si trasferì a Berlino non solo per raggiungere quello che allora era considerato il centro del mondo ed ospitava il più attivo e numeroso gruppo psicoanalitico d’Europa, ma anche per sottrarsi alla diffidenza ed ai sospetti che su di lui gravavano da parte di una fitta schiera di psicoanalisti viennesi. A nulla sarebbe valso questo spostamento, rispetto al desiderio di recuperare una posizione solida nell’ambito dell’organizzazione psicoanalitica internazionale. In pochi anni, la posizione di Reich si sarebbe fatta, suo malgrado, insostenibile. Le sue posizioni politiche lo facevano, infatti, apparire, ai suoi colleghi psicoanalisti, come un pericoloso estremista rivoluzionario. Nel 1934, durante il XIII Congresso, svoltosi a Lucerna, Reich fu definitivamente espulso dall’Associazione Psicoanalitica Internazionale (1).
Per ironia della sorte, l’anno precedente, nel 1933, egli era stato espulso anche dal partito comunista tedesco. Paradossalmente, in questo caso, le motivazioni erano opposte. I compagni comunisti vedevano, nello psicoanalista Reich, interessato alla sessualità e alla mente umana, un borghese corrotto e individualista. Bisogna ricordare che la sua fiducia nella politica comunista e rivoluzionaria subì un duro colpo nel 1929, quando fece un viaggio in Unione Sovietica. Lì Reich aveva, tra gli altri, conosciuto personalmente Vera Schmidt e preso contatto con diverse istituzioni pedagogiche post-rivoluzionarie ma, il paese dei Soviet, verso cui tutti gli spiriti progressisti del tempo guardavano con speranza, si stava trasformando in una dittatura. Le riforme sociali dei primi anni, seguiti alla rivoluzione, stavano cedendo il passo al ritorno della vecchie regole di comportamento e di una morale oppressiva, sancita, anche, giuridicamente. Questa esperienza diede, poi, vita al volume La rivoluzione sessuale (1936), in cui venivano espresse le sue critiche.
Dopo il trasferimento a Berlino, nel 1930, i contatti tra l’allievo e Freud si diluirono. Del resto Freud stesso non aveva posto particolari e personali resistenze a questo trasferimento, avallando, sostanzialmente, la posizione di Federn, ostile a Reich e limitandosi a generiche rassicurazioni e saluti nei confronti dell’allievo.
In effetti, il Freud di quegli anni, oltre ad essere un grande studioso che pubblicava, periodicamente, opere fondamentali per lo sviluppo della psicoanalisi, era anche l’attento regista teso alla realizzazione di una solida e duratura istituzione psicoanalitica internazionale, con le sue regole ed i suoi rituali.
Una minuziosa cronaca che illustra, tra l’altro, gli anni di Freud tra il 1924 ed il 1930, ci viene offerte nella Vita e opere di Freud (1953) di E. Jones. Sul piano personale, la figura del fondatore della psicoanalisi ci viene proposta come quella di un uomo molto sofferente per la malattia che lo ha colpito e profondamente impegnato nei tanti risvolti e nelle controversie legate al consolidamento di quella istituzione psicoanalitica internazionale, che avrebbe dovuto proteggere il futuro sviluppo della disciplina. Tra gli esponenti dell’istituzione psicoanalitica scoccavano, continuamente, scintille d’amore e d’odio; inoltre nascevano infiniti problemi legati alla pubblicazione dei molti lavori. Sotto questo aspetto la vicenda di Reich rappresentò, per Freud, una situazione come molte. Tra l’altro, Reich era sempre stato un acerrimo contestatore della teoria delle pulsioni revisionata, proposta da Freud in Al di là del principio del piacere (1920). In essa, modificando le primitive concezioni esposte nei Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), dove si individuava, nella libido, una unica forza variabile quantitativamente, veniva invece ipotizzata l’esistenza di due pulsioni fondamentali: l’Eros, o pulsione di vita e il Thanatos, o pulsione di morte. Secondo questa proposta, il Thanatos si manifesta nella forma di desideri distruttivi, dapprima verso se stessi (masochismo primario) e, in seguito, verso altre persone e il mondo esterno. Ciò, per il marxista Reich era inaccettabile, poiché la distruttività, nel suo divenire, doveva essere il risultato dei condizionamenti negativi, operati proprio dal mondo esterno, sull’individuo. Una prospettiva che, oltre a Marx, riecheggiava Rousseau.
Poco dopo il suo trasferimento a Berlino, Reich aveva proposto il suo scritto Der masochistische charakter (1932), per la pubblicazione sull’Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. Riferisce E. Jones (1953, vol. 3, 198) che: «Il lavoro, secondo Freud, “culminava nella stolida affermazione che quello che abbiamo chiamato istinto di morte è un prodotto del sistema capitalistico”, differendo in questo dalle vedute del fondatore della psicoanalisi, secondo le quali esso rappresenta una tendenza innata di tutti gli esseri viventi, animali e vegetali. Freud volle aggiungere un commento editoriale nel quale sconfessare qualsiasi intento politico della psicoanalisi, cosa che in qualità di editore anch’io non avrei esitato a fare. Reich acconsentì, mentre Eitingon, Ludwing Jekels e Bernfeld, consultati da Freud, si dissero contrari; Bernfeld aggiunse che ciò sarebbe equivalso a una dichiarazione di guerra ai sovietici! Freud allora esitò, ma non volle accettare nemmeno la proposta di Ferenczi, e cioè che l’Esecutivo Internazionale gli facesse formale richiesta affinché ogni collaboratore della Zeitschrift dichiarasse se apparteneva o no a un qualsiasi corpo extra-scientifico. La faccenda fu infine sistemata mediate la pubblicazione del lavoro di Reich, seguito però da una critica a fondo di Bernfeld».
Come si constata, le idee del giovane Reich davano parecchi problemi alle gerarchie intellettuali della istituzione psicoanalitica. L’episodio riportato da Freud è solo il culmine di uno dei vari conflitti che, in più casi, avevano avuto origine ancor prima del periodo relativo alla corrispondenza qui esaminata.
Per altri, più limitati, aspetti il discepolo si esprimeva in modo assai sintonico rispetto alle idee del maestro. Nel saggio Il carattere pulsionale (1925), Reich affronta, tra l’altro, il concetto di Super-Io, in pieno accordo con molte proposte avanzate da Freud in Inibizione sintomo e angoscia (1925), pubblicato in quello stesso anno. In quest’opera, il fondatore della psicoanalisi riprendeva il tema dell’angoscia nevrotica, cambiandone l’interpretazione, alla luce di quella complessiva e rinnovata teoria psicoanalitica della personalità precedentemente esposta ne L’io e l’Es (1923). Inizialmente, Freud aveva pensato che l’angoscia del soggetto nevrotico consistesse nella conversione della libido, impedita a manifestarsi a causa della sua natura sessuale, dall’azione della rimozione. In questa ipotesi rimaneva però inspiegato il meccanismo che mette in moto il processo della rimozione. E’ l’individuazione del Super-Io che consente di cogliere la reale eziologia dell’angoscia. La sede dell’angoscia, che prima veniva indicata nello stesso moto pulsionale, viene ora ricercata nell’Io. Solo l’Io può provare il sentimento di pericolo imminente che sempre accompagna ogni specie d’angoscia, compresa quella nevrotica. Viene così a essere capovolto il rapporto tra rimozione e angoscia: non più quella come causa di questa, ma sarebbe l’angosciarsi dell’Io a provocare esso stesso la rimozione delle pulsioni dell’Es, avvertite dall’Io come un pericolo da temere. In effetti, l’Io ha paura delle sanzioni del Super-Io, qualora le pulsioni, da questo proibite, possano essere appagate.
Questo schema risultava, a Reich, pienamente consono al suo pensiero. Egli considerava il Super-Io come la formazione mentale individuale destinata a difendere le regole imposte, dalla coscienza morale sociale, alla persona. Il Super-Io, per Reich, rappresentava e difendeva i divieti che la civiltà impone agli istinti. Esso costituiva il principale strumento di ciò che avrebbe intitolato L’irruzione della morale sessuale (1932).
Le differenze maggiori, tra i due personaggi riguardano, piuttosto, le tematiche di ordine storico e sociale, relative alla religione e allo sviluppo della civiltà umana, che Freud andava, sistematicamente, affrontando proprio nella seconda metà degli anni venti. Ne L’avvenire di una illusione (1927), il pessimismo freudiano si rivolge verso la religione, a cui nega ogni valore oggettivo di verità. Sulla base di una ispirazione di stampo illuministico, aggiornata secondo gli orientamenti materialistici del positivismo tedesco di fine secolo, Freud riconduce la religione al bisogno umano di una compensazione alle angosce. In questa prospettiva, la religione sarebbe un pensiero consolante, simile a quello con cui il bambino reagisce al sentimento della propria debolezza e si rifugia fra le braccia del padre.
Queste idee non avrebbero, storicamente, trovato nessuna, particolare, resistenza all’interno del pensiero di Reich, anch’egli orientato secondo i canoni di una filosofia materialista, lontana da ogni accordo con le proposte convenzionali di spiritualità. L’allievo avrebbe, invece, profondamente sofferto per la successiva proposta intellettuale del maestro: Il disagio della civiltà (1929). Il tema centrale di quest’opera è l’antagonismo inconciliabile fra la pretesa di felicità dell’individuo e le barriere imposte dalla civilizzazione. Per l’impostazione antropologica freudiana, il principio del piacere è in disaccordo con tutto il mondo. Esso è minacciato da tre fonti di sofferenza; ossia dallo strapotere della natura esterna, dall’impotenza della natura interiore (malattia e morte) e dai rapporti soggettivi, caratterizzati da aggressività e conflitti. A causa di tutto ciò, l’uomo si pone sotto la protezione della civiltà e scambia buona parte delle possibilità di essere felice con un po’ di sicurezza. E’ una interpretazione profondamente pessimistica, rispetto al rapporto tra i bisogni pulsionali dell’individuo e le esigenze superiori della società e della civiltà.
Questo pessimismo freudiano non poteva, assolutamente, essere accolto all’interno delle concezioni teoriche di Reich. Quest’ultimo, infatti, marxista e sostenitore del bolscevismo della prima ora, subiva, in quegli anni, la suggestione del mito dello “uomo nuovo” sovietico. Il mito nasce con Marx ed Engels che, ne L’ideologia tedesca (1846), sostennero che, nella società capitalistica, a causa della divisione del lavoro e della scissione tra lavoro fisico e lavoro intellettuale, l’individuo realizza la propria intelligenza e la propria personalità solo in modo unilaterale e parziale, soddisfacendo i bisogni limitati, che emergono in una vita scissa e alienata. Il comunismo consentirebbe, invece, all’individuo la riappropriazione della propria natura alienata e la ricomposizione tra attività materiale e attività intellettuale. In tal modo si creerebbero le condizioni per la realizzazione di un uomo nuovo, un “uomo omnilaterale”. Gli psicologi e i pedagogisti sovietici del periodo post-rivoluzionario si impegnarono nella realizzazione di una nuova scuola, volta a tal fine, tramite la proposta di una educazione non coercitiva e libertaria, rispetto alle potenzialità individuali. L’asilo psicoanalitico di Mosca, in cui lavorarono Vera Schmidt e Sabina Spilrein è un esempio di queste iniziative. Bisogna considerare che, nel decennio posteriore alla rivoluzione d’Ottobre, l’uomo nuovo divenne un progetto concreto, che coinvolse, nella sua realizzazione, buona parte della società sovietica. Anche da questo progetto venne il grande interesse che il rinnovamento culturale, seguito alla rivoluzione, dimostrò nei confronti delle nuove teorie pedagogiche e nei confronti del pensiero psicoanalitico. D’altro canto, gli psicoanalisti d’ispirazione marxista, come Reich e, in quel periodo, anche Otto Fenichel (Angelini, 2009), erano profondamente suggestionati dal mito dell’uomo nuovo. Essi credevano, con la psicoanalisi, di poter cambiare il mondo. La dimensione utopica è congrua, rispetto al pensiero di Reich; essa affiora, più o meno marcatamente, in tutti i suoi scritti, compresi quelli, della seconda parte della sua vita, che seguirono il suo allontanamento dalla prospettiva psicoanalitica. Reich crede nella liberazione dai bisogni pulsionali, come i comunisti sovietici credevano nella liberazione dai bisogni materiali; anzi, egli crede sia necessario liberare l’individuo da entrambi questi bisogni e prefigura, in più occasioni, un soggetto liberato che si ispira molto, almeno per certi aspetti, all’utopia dell’uomo nuovo sovietico. Non sono tanto importanti le differenze tecniche, nel pensiero dell’allievo, rispetto alle valutazioni filosofiche del maestro, quanto la fede di Reich nell’utopia di una plausibile libertà del soggetto. In ciò, egli differiva, profondamente, dal pessimismo di Freud e, dal carteggio qui esaminato, risulta come il fondatore della psicoanalisi avesse percepito questa opposizione.
Sul piano storico, bisogna però ricordare che le critiche e la condanna di Reich giunsero al termine di una lunga parabola che lo aveva visto, agli esordi, apprezzato e sostenuto da Freud.
Nella biografia redatta dalla seconda moglie, Ilse Ollendorf Reich, troviamo scritto: «Quando Reich iniziò ad operare nell’ambito del movimento psicoanalitico, Freud lo considerava uno dei suoi assistenti più brillanti: Reich era per lui un “figlio prediletto” e aveva libero accesso a casa sua, dove egli era sempre pronto ad accoglierlo per discutere di qualche problema, ogni volta che se ne presentasse la necessità. A quell’epoca, Freud considerava quell’insistenza sull’origine sessuale delle nevrosi come lo Steckenpferd (pallino) di Reich» (I. O. Reich, 1968, 38). Anche ridimensionando la passione con cui la Ollendorf descrive le vicende del marito è plausibile credere che il giovane entusiasta sia piaciuto al fondatore della psicoanalisi. Scrisse, infatti, Freud a Loù Andreas Salomé, ancora nel 1928: «Abbiamo qui un certo dottor Reich, un giovane di valore, ma impetuoso, dedito con passione alla sua “idea fissa”, il quale attualmente saluta nell’orgasmo genitale l’antidoto contro qualsiasi tipo di nevrosi» (1983, 172).
l’esplosione del dissidio tra i due risale, sempre secondo la Ollendorf, all’inizio del 1927 e viene indicata anche una motivazione personale, oltre ai motivi ideologici e teorici che si sono descritti sopra. “Secondo Annie Reich (prima moglie), la grave frattura fu causata dal rifiuto di Freud ad occuparsi dell’analisi personale di Reich; da principio Freud sembrava disposto ad accettarlo, ma in seguito decise che non poteva o non voleva contravvenire alla regola da lui stesso stabilita, secondo la quale non avrebbe mai accettato un membro della sua cerchia viennese per analisi personale: Reich, da parte sua, attribuì la rottura a divergenze di ordine teorico, soprattutto riguardo alle implicazioni sociali della psicoanalisi ed ai tentativi di altri analisti, tra cui Paul Federn, di screditarlo agli occhi di Freud» (I. O. Reich, 1968, 39). Nella stessa pagina, la Ollendorf suggerisce l’idea di un complesso paterno, da parte di Reich verso Freud, che avrebbe reso intollerabile il rifiuto da parte del maestro e provocato, nell’allievo, una profonda depressione. Comunque siano andate le cose è sempre dal 1927, anno in cui fu anche pubblicata La funzione dell’orgasmo, che la parabola di Reich, presso Freud e la cerchia psicoanalitica viennese, mostra la sua fase discendente. Questa parabola negativa non si sarebbe interrotta nemmeno con il trasferimento di Reich a Berlino, nel 1930 e può dirsi, idealmente, conclusa solo con l’espulsione di Reich dall’Associazione Psicoanalitica Internazionale, nel 1934. Dopo questo, egli iniziò una vita completamente diversa. La corrispondenza che, di seguito, riportiamo suggerisce di collocare l’inizio della discesa di tale parabola nella lettera 5 che, come si illustrerà, esprime l’obiezione di Freud alla risoluzione genitale dei sintomi, nelle nevrosi attuali.
Nelle lettere precedenti alla 5, il tono di Freud era più morbido e colloquiale; a partire dalla lettera 1, del 26 giugno 1924, in cui il maestro sembra bonariamente ricordare all’allievo, impegnato nella sua opera, di non trascurare i contributi e gli studi altrui. Scrive, tra l’altro, il fondatore della psicoanalisi: “La terapia psicoanalitica è ora in movimento, a causa delle innovazioni di Ferenczi e Rank”. Sono poche parole, ma aprono uno spiraglio sulle vivaci dinamiche interne che il mondo psicoanalitico sperimentava, in quel periodo. Freud era molto affezionato a Ferenczi; i due uomini si scambiarono più di 1500 lettere in venticinque anni. Fin dall’inizio, Ferenczi fu anche presente nel comitato concepito, nel 1912, da Ernest Jones per difendere il pensiero di Freud e lo sviluppo della psicoanalisi. Tuttavia il fondatore della psicoanalisi aveva opinioni contrastanti riguardo alle innovazioni tecniche proposte da Ferenczi. Quest’ultimo, in quegli anni, stava proponendo l’idea di un “tecnica attiva” nella terapia psicoanalitica. Questa proposta che, sintetizzando, suggerisce una più intensa partecipazione affettiva, per i protagonisti del rapporto fra paziente e analista, diede e dà, ancor oggi, vita ad un animato e controverso dibattito. Ferenczi, che rimase sempre nel cuore di Freud, nell’ultima parte della sua vita, prima di scomparire nel 1933, ebbe, con il fondatore della psicoanalisi, un lungo e vivace diverbio sull’argomento della tecnica psicoanalitica. Non a caso, Freud cita assieme Ferenczi e Rank. Anche con quest’ultimo, in quegli anni, si andavano sviluppando malintesi personali e conflitti teorici che sarebbero culminati, nel 1929, con le dimissioni di Rank dall’Associazione Psicoanalitica Internazionale. Verrebbe da pensare che l’irrequietezza del giovane Reich evocava in Freud le controversie, già in atto, con gli altri due storici personaggi del movimento psicoanalitico. Dalle parole di Freud si deduce, inoltre, che Reich aveva, probabilmente, proposto il progetto di pubblicare una opera compilativa sulla tecnica psicoanalitica: “Potrebbe non essere il momento più adatto per tentare di fornire una esposizione, in qualche modo, perfezionata”. Ciò è possibile, perché proprio in quell’anno, il 1924, in piena parabola ascendente, Reich era stato nominato direttore del Seminario Tecnico Psicoanalitico, Quindi è ragionevole supporre che la sua mente fosse orientata verso problematiche didattiche, legate alla trasmissione del sapere psicoanalitico. Freud prosegue la sua lettera con un invito alla cautela, ricordando come il compito sia arduo. Non a caso, la lettera si conclude citando Hanns Sachs che, dopo il suo trasferimento a Berlino, pochi anni dopo, si sarebbe posto il compito di organizzare la prima struttura di formazione degli analisti, in quella città. Sachs non si allontanò mai, minimamente, dall’ortodossia del pensiero indicato dal maestro e, nell’organizzare questo primo istituto per il training si propose due scopi: “ Di insegnare le linee di comprensione dell’inconscio, così faticosamente scoperte da Freud e dai suoi primi collaboratori e di rafforzare l’obbedienza assoluta alla posizione teorica della scuola” (Fine, 1979, 70).
Quel che attrae l’attenzione di Freud, nella lettera 2, del 14 dicembre 1924, è, in particolare, la dinamica delle relazioni tra Io e Super-Io. Il parere del maestro, con alcune riserve per l’impiego futuro di qualche termine proposto da Reich, è favorevole. E probabile che Freud abbia letto una stesura relativa a Il carattere pulsionale: uno studio psicoanalitico sulla patologia dell’Io (1925), lavoro pubblicato l’anno dopo. In questo scritto, come si è già accennato, Reich sviluppa lo studio delle dinamiche psichiche appartenenti alla formazione del Super Io, in sostanziale sintonia con molti concetti, precedentemente, esposti da Freud ne L’Io e l’Es (1923). Freud critica “una certa mancanza di chiarezza e un eccesso di interrogativi, nella prima parte”; ma conclude con parole di lode: “Il suo lavoro, in ogni caso, rappresenta un notevole progresso nella conoscenza di quelle forme morbose che trovano probabilmente il loro culmine nella moral insanity”. Con questa definizione, Freud riprendeva una vecchia terminologia, proposta nel 1835 da J. C. Prichard, per descrivere quegli individui in cui, pur restando inalterate le operazioni intellettuali, appaiono profondamente sovvertite la condotta e l’affettività.
Dalla lettera 3, del 21 dicembre 1924, emerge, nuovamente, il desiderio di Reich di scrivere un volume, presumibilmente un manuale, sulla tecnica psicoanalitica e la speranza che il maestro avalli il suo progetto. Freud fa capire di non essere convinto riguardo all’urgenza di questa iniziativa, ma dichiara che, eventualmente, “preferirei naturalmente che fosse lei a scriverlo, piuttosto che uno sconosciuto, verosimilmente meno esperto”. Questa impellente aspirazione di Reich a pubblicare un volume di tecnica trova le sue radici nella complessa situazione scientifica ed esistenziale che egli, allora, viveva. In quel periodo, oltre a dirigere il Seminario Tecnico Psicoanalitico, Reich era il vicedirettore del cosiddetto Ambulatorium, un Centro Clinico, diretto da Eduard Hitschmann e fondato nel 1922, che si proponeva di offrire la cura psicoanalitica a chiunque ne avesse bisogno, prescindendo dalle sue disponibilità economiche.
Questa iniziativa nasceva sulla scia di un analogo progetto avviato a Berlino nel 1920: il “Policlinico Psicoanalitico”.
Riecheggiavano, in queste concrete proposte, offerte alla popolazione, alcune generali indicazioni di principio che lo stesso Freud aveva espresso durante una conferenza, tenuta al Congresso di Budapest nel 1918, quando lamentò come “le necessità della nostra esistenza circoscrivono la nostra possibilità di intervento ai ceti superiori e benestanti della società”(Freud 1918, 26-27).
Nel periodo in cui Freud teneva la sua conferenza, veniva instaurata la Repubblica Sovietica d’Ungheria, che affidava a Sandor Ferenczi una cattedra di psicoanalisi presso l’Università di Budapest. Storicamente, fu il primo spazio accademico conquistato dal movimento psicoanalitico, anche se l’incarico durò quanto il governo stesso, circa cento giorni. Durante quella breve rivoluzione, a György Lukács fu anche affidata la responsabilità di Commissario alla Cultura.
In seguito, il fondatore della psicoanalisi riconobbe, in occasione del decimo anniversario dalla fondazione, i valori umani e sociali espressi dal Policlinico Psicoanalitico Berlinese, che si adoperava “per rendere accessibile la nostra terapia a quelle grandi masse di uomini e donne che, sebbene non soffrano meno, a causa delle loro nevrosi, di quanto soffrano i ricchi, non hanno tuttavia la possibilità di affrontare la spesa di un trattamento” (Freud, 1930, 29).
E’, appunto, in questo contesto che, nel 1920, a Berlino, al 29 di W. Potsdamer Strasse, era sorto il “Policlinico Psicoanalitico”, sotto l’egida dell’Istituto. Esso conteneva un vero e proprio “Centro di Prima Consultazione” (Angelini, 2002a), teso a stabilire un contatto organico tra le istituzioni psicoanalitiche e il mondo esterno; lo dirigevano Eitingon e Simmel. Bisogna, anche, ricordare la presenza di Karl Abraham, Franz Alexander, Paul Federn, Edith Jacobson, Karen Horney e Melanine Klein. Una forte influenza fu poi esercitata da alcuni analisti ideologicamente vicini alla sinistra marxista, come Helene Deutsch, Erich Fromm, Siegfried Bernfeld e Wilhelm e Annie Reich, dopo il loro trasferimento da Vienna, nel 1930.
Il Policlinico berlinese rappresentò il primo contributo concreto della psicoanalisi alle trasformazioni della società occidentale.
L’Ambulatorium viennese nacque ispirandosi a questa precedente iniziativa. Esso era collocato in un seminterrato, senza finestre e coloro che svolgevano l’attività clinica, accogliendo chi chiedeva un colloquio, erano, in linea di massima, gli stessi che partecipavano al Seminario Tecnico Psicoanalitico, gestito da Reich. In questa sua attività didattica, egli cambiò il modo di scrivere le schede cliniche. Da descrizioni cariche di sintomi, minuziosamente elencati, a ritratti narrativi tesi a descrivere globalmente la personalità dell’individuo e a collocarlo nel suo contesto sociale e lavorativo (Danto, 2011). Riecheggia anche qui, sul piano clinico, più che teorico, una certa sintonia col pensiero degli psicoanalisti sovietici e, in particolare, con A. Luria che, per tutta la vita, avrebbe propugnato questa linea di intervento, nella clinica.
La lettera 4, del 28 maggio 1925, è un semplice attestato, in cui Freud certifica la formazione e il valore tecnico e teorico dell’allievo, in quanto psicoanalista. Il testo esprime aperta stima. Ci sono, poi, diversi mesi di pausa, in cui Reich prosegue le sue attività didattiche, cliniche e di scrittura ma, poco più di un anno dopo, la sua parabola sembra aver raggiunto il culmine e prossima ad iniziare la discesa.
Nella lettera 5, del 9 luglio 1926, Freud avanza chiare critiche all’allievo. Il fondatore della psicoanalisi dichiara di aver letto un manoscritto inviato da Reich. Si tratta, con ogni probabilità de La funzione dell’orgasmo (1927), pubblicata pochi mesi dopo. Questo testo non poteva essere accolto positivamente né da Freud né dal cauto ambiente psicoanalitico viennese. Il volume, per la maggior parte, sembra trattare quasi solo argomenti relativi alla tecnica e alla teoria psicoanalitiche. Tutto è declinato in una prospettiva energetica che vede, nella sessualità, il fondamento di ogni dinamica psichica, normale e patologica. Troviamo argomenti come i disturbi psichici dell’orgasmo, la stasi somatica della libido, l’eziologia psichica delle nevrosi attuali, l’astenia genitale nella nevrastenia ipocondriaca e così via. Come già illustrato, Freud criticò, direttamente, l’ipotesi di una origine sempre genitale dei sintomi nevrotici; ma il testo di Reich, se lo propose al maestro nella sua interezza, era inquietante, per l’istituzione psicoanalitica, anche per altri motivi.
Nella seconda parte del volume, Reich volge l’attenzione alle implicazioni sociali della repressione sessuale e della morale coercitiva. La sua idea è che gli impulsi distruttivi e sadici dipendano, fondamentalmente, dalla stasi sessuale; questa posizione è evidentemente conflittuale con la teoria della pulsione di morte freudiana. In questa prospettiva, si lancia in una serie di esempi storici che toccano sia il passato, come l’epoca dell’Inquisizione, sia i fenomeni, suoi contemporanei, espressione del sadismo e del nazionalismo che covano nella Germania di Waimar. Apparentemente meno critico, Reich è nei confronti delle cosiddette “illusioni operaistiche”. Ciò è dovuto, probabilmente, al suo avvicinamento al partito comunista austriaco, a cui si sarebbe iscritto l’anno dopo. Mentre, ancora, crede nella maggior “salute morale e psichica” del proletariato, non sa spiegarsi “perché le masse si lascino dominare dai singoli”; ovvero la tragica passività delle persone inserite in movimenti gregaristici ed autoritari, sia di destra, sia di sinistra. A questo specifico tema Reich avrebbe dedicato uno particolare saggio, qualche anno dopo: Psicologia di massa del fascismo (1933). Infine, nell’ultima parte del volume, Reich avanza le sue prime critiche al matrimonio monogamico e alla morale sessuale dominante. Questo tema sarebbe stato, sistematicamente, ripreso nelle pubblicazioni degli anni successivi.
Non c’è bisogno di aggiungere altro per comprendere che una personalità come Freud, sia scientificamente, sia culturalmente, non poteva recepire questo tipo di argomenti. La lettera si conclude con la comunicazione, da parte del maestro, che la casa editrice dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale, per motivi economici, non è in grado di pubblicare il manoscritto di Reich e con l’invito ad apportare riduzioni e modifiche al testo, in vista di tempi, economicamente, migliori per una edizione. In effetti, la casa editrice psicoanalitica versava in gravi condizioni economiche e sopravviveva in virtù di donazioni e della cessione dei diritti d’autore, da parte di Freud, ma anche se fosse stata finanziariamente fiorente, il lavoro di Reich non sarebbe stato pubblicato.
Nella lettera 6, del 6 febbraio 1927, apprendiamo che Reich si trova a Davos, in Svizzera e chiede a Freud di raccomandarlo, presso il pastore Oscar Pfister e la dottoressa Emily Oberholzner, affinché gli inviino pazienti. In quel periodo, Reich era stato colpito da una incipiente affezione tubercolare ai polmoni. Peraltro il fratello ed il padre erano morti di tubercolosi. Dovette, quindi, ricoverarsi nel sanatorio di Davos, dove continuò a scrivere e a studiare attivamente. Aspirava, perfino, ad esercitare, lì, la professione, sebbene Freud, attento alle regole, gli avesse scritto: “ Il divieto di pratica per coloro che non sono svizzeri mi sembra, tuttavia, un grosso ostacolo”.
Percepiamo, nella lettera 7 del 15 luglio 1927, un tono diverso da parte di Freud, che si libera, questa volta, dal suo ruolo patriarcale. Essa fu scritta in una giornata di particolare tensione sociale, a Vienna.
Precedentemente, il 30 gennaio 1927, nella cittadina di Schattendorf, in occasione di un comizio socialista, un gruppo di ex combattenti di destra, nostalgici del Kaiser, aveva aperto il fuoco sulla folla, a sangue freddo, uccidendo un bambino e ferendo gravemente molte persone. Sorprendentemente, gli assassini erano riusciti a dileguarsi, senza che la folla li aggredisse. In seguito, però, furono catturati e sottoposti a processo. Il 14 luglio 1927, una corte di magistrati politicamente reazionari assolveva gli assassini e li mandava liberi, dopo un processo condotto con vergognosa parzialità. Il giorno dopo, 15 luglio, quando fu scritta la lettera, gli operai viennesi insorsero, occupando il centro della città. Molti reparti di polizia furono fatti confluire da varie zone del paese e, in molte situazioni, i poliziotti spararono sulla folla, causando diversi morti. Il Palazzo di Giustizia fu dato alle fiamme ma, in linea di massima, non vi furono, da parte della folla, particolari violenze verso la polizia. Ciò anche perché il partito comunista austriaco aveva dato ordine al suo servizio di sicurezza, lo Schutzbund, di non intervenire. Quando Freud scrisse la lettera, la folla e la polizia si fronteggiavano nelle strade, nei pressi della sua casa e nell’aria echeggiavano gli spari dei poliziotti. Il fondatore della psicoanalisi abbandonò ogni tono formale e rimandò qualunque incontro a settembre, “sempre che allora il mondo esista ancora”.
Nella lettera 8, del 27 luglio 1927, si avverte, purtroppo, che alcuni dei nodi, depositati dalla irruente personalità di Reich nel cauto ambiente psicoanalitico viennese, stavano venendo al pettine. Certamente, un personaggio esuberante come Reich non aveva avuto difficoltà a crearsi degli acerrimi avversari. Bisogna anche aggiungere che diversi colleghi psicoanalisti e la stessa prima moglie, Annie Pink Reich, lo giudicarono molto cambiato e provato, psicologicamente, dopo il suo ritorno da Davos (I. O. Ollendorf, 1968, 40). Valutando, storicamente, la situazione, però, gli aspetti caratteriali di Reich influivano poco. Freud e i vertici dell’istituzione psicoanalitica viennese erano preoccupati per i contenuti ideologici estremisti che, in quanto direttore del Seminario Tecnico Psicoanalitico, egli avrebbe potuto trasmettere ai giovani, futuri analisti, in formazione. Così, dopo aver minimizzato il peso che le voci dei suoi avversari avrebbero potuto avere sul suo giudizio personale, Freud scrive a Reich che “è dunque giustificato chiederle di mantenere separati la sua ricerca personale e il suo insegnamento e di presentare ai giovani ciò che è già patrimonio comune, senza impegnarli, per il momento, con le sue innovazioni”.
La lettera 9, del 22 novembre 1928, contiene l’ultimo deposito di ambivalente benevolenza, da parte di Freud, verso l’allievo. L’ambivalenza è molta, perché la lettera esordisce comunicando che, all’indomani di una “conversazione del tutto amichevole” con Reich, il fondatore della psicoanalisi si è dichiarato favorevole all’esonero di quest’ultimo dal Seminatio Tecnico Psicoanalitico. Emerge il nome di Paul Federn, come principale oppositore e critico di Reich, nell’ambito dei vertici psicoanalitici viennesi. Freud dichiara: “Devo essere pronto ad accogliere le richieste dei miei rappresentanti”, lasciando, apertamente, intendere che è stato, proprio, Federn a proporre l’allontanamento di Reich; poi rammenta i molti impegni lamentati dall’allievo, che gli sottrarrebbero ogni spazio di tempo. Tuttavia, nell’ultima parte della lettera, riecheggia una eco dell’antica e patriarcale benevolenza del fondatore della psicoanalisi verso il giovane seguace. Freud dichiara di essersi consultato con la figlia e scrive: “Ho capito che sbagliavo. Se non desidera lasciare la direzione del Seminario…questa non può esserle sottratta contro la sua volontà. Scriverò oggi stesso al dottor Federn in tal senso”. Effettivamente, Reich rimase direttore del Seminario fino al 1930, anno del trasferimento a Berlino. E’ chiaro, però, che la sua credibilità ed i suoi spazi di manovra, all’interno dell’istituzione psicoanalitica viennese erano estremamente ridotti.
Nella lettera 10, del 10 ottobre 1930, scritta quasi due anni dopo, ogni residuo dubbio, da parte di Freud, è cancellato: “Non posso prendere partito contro il modo di regolare la questione adottato dal dottor Federn”. Si evince che quest’ultimo, approfittando del trasferimento di Reich a Berlino, aveva escogitato una procedura tesa ad estrometterlo dal Seminario. Si intuiscono delle obiezioni formali, relative alla procedura adottata, che l’allievo faceva presenti al maestro. Tuttavia, dalle parole di Freud, si comprende che egli non ha dubbi. Ritiene che Reich debba abbandonare il Seminario e la procedura tecnica è solo un dettaglio formale: “Non riesco dunque a scaldarmi riguardo alla realizzazione tecnica del suo congedo”.
Pochi giorni dopo, Reich partiva per Berlino, lasciandosi alle spalle sia i conflitti, sia gli affetti del mondo viennese e si dirigeva verso quello che allora era considerato il centro d’Europa e del mondo. Non poteva immaginare che quel viaggio sarebbe stato il primo tratto di una lunga serie di peregrinazioni, che si sarebbe conclusa, solo, con il suo trasferimento negli Stati Uniti.
(1) Al Congresso di Lucerna, dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale, nel 1934, parteciparono tre studiosi italiani: Edoardo Weiss, Nicola Perrotti ed Emilio Servadio. Chi scrive ha avuto modo di raccogliere una testimonianza diretta sull’avvenimento, da Servadio. Durante i lavori del Congresso, si era già sparsa la voce che l’Associazione avrebbe espulso Wilhelm Reich. I rapporti personali tra quest’ultimo ed i partecipanti, di lingua tedesca, erano molto tesi e, in alcuni casi, decisamente conflittuali. Nell’occasione della cena sociale, i commensali tendevano a riunirsi in tavoli abbastanza omogenei per nazionalità e lingua. Quando Reich entrò nel salone, però, cercò invano un posto tra i suoi colleghi austriaci e tedeschi. Nessuno di loro voleva accoglierlo e si creò uno stato di tensione. Fu il gruppo degli italiani a sbloccare la situazione, invitando al proprio tavolo Wilhelm Reich. Egli trascorse la sua ultima serata sociale, come esponente dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale, assieme a Weiss, Perrotti e Servadio.
BIBLIOGRAFIA
Adler M. (1925), «Erkenntniskritische Bemerkungen zur Individualpsychologie»,
Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, III.
Angelini A. (1984), «Wilhelm Reich nel dibattito psicoanalitico degli anni trenta»,
Storia e critica della psicologia, 2.
Angelini A. (1985), «La psicoanalisi e l’energetismo di Wilhelm Ostwald», Giornale
Storico di Psicologia Dinamica, 17.
Angelini A. (1988), La psicoanalisi in Russia, Liguori, Napoli.
Angelini. A. (2002), Pionieri dell’inconscio in Russia, Liguori, Napoli.
Angelini. A. (2002a), «Note storiche sulla prima consultazione psicoanalitica»,
Rivista di Psicoanalisi, 3.
Angelini A. (2008), «History of the unconscious in Soviet Russia: From its origins to
the fall of the Soviet Union», International Journal of Psychoanalysis, 2.
Angelini A. (2009), Un enciclopedista romantico:psicoanalisi e mondo sociale
nell’opera di Otto Fenichel. Liguori, Napoli.
Danto E. (2011), «An Anxious Attachment: Letters from Sigmund Freud to Wilhelm
Reich», Contemporary Psychoanalysis, 2.
Deborin A. M. (1924), «Lukács e la sua critica del marxismo», in: A.A. V.V.,
Intellettuali e coscienza di classe (a cura di L. Boella), Feltrinelli,
Milano, 1977.
Freud S., Salomé L. A. (1983), Eros e conoscenza – Lettere tra Freud e Lou Andreas
Salomè 1912-1936, Torino, Boringhieri.
Freud S. (1894), Le neuro psicosi di difesa, O.S.F., 2.
Freud S. (1895), Progetto per una psicologia, O.S.F., 2.
Freud S. (1896), L’eredità e l’eziologia delle nevrosi, O.S.F., 2.
Freud s, (1898), La sessualità nell’eziologia delle nevrosi, O.S.F., 2.
Freud S. (1905), Tre saggi sulla teoria sessuale, O.S.F., 4.
Freud S. (1912), Contributi ad una discussione sull’onanismo, O.S.F., 6.
Freud S. (1915-17), Introduzione alla psicoanalisi, O.S.F., 8.
Freud S. (1918), Vie della terapia psicoanalitica, O.S.F., 9.
Freud S. (1920), Al di là del principio del piacere, O.S.F., 9.
Freud S. (1923), L’io e l’Es, O.S.F., 9.
Freud S. (1925), Inibizione sintomo e angoscia, O.S.F., 10.
Freud S. (1927), L’avvenire di una illusione, O.S.F., 10.
Freud S. (1929), Il disagio delle civilta, O.S.F., 10.
Freud S. (1930), Prefazione a: Dieci anni dell’istituto Psicoanalitico di Berlino,
O.S.F., 11.
Fine R. (1979), Storia della Psicoanalisi, Boringhieri, Torino.
Jones E. (1953), Vita ed opere di Freud (3 voll.), Il Saggiatore, Milano, 1962
Jurinetz V. (1925), «Psychoanalyse und Marxismus», Unter dem Banner des
Marxismus, I; ristampato in A.A. V.V., Psychanalyse und marxismus,
Dokumentation einer Kontroverse. Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1970.
Kornilov K.N. (1925), Psichologija i Marksizm, Gosizdat, Mosca.
Korsch K. (1923), Marxismo e Filosofia, Milano, Sugar, 1966.
Lukács G. (1923), Storia e coscienza di classe, Milano, Sugar, 1967.
Luria A.R. (1925), «La psicoanalisi come sistema di psicologia monista», in:
Angelini A. (2002), op. cit.
Luria A. R. (1926), “La moderna fisiologia russa e la psicoanalisi”, Giornale Storico
di Psicologia Dinamica, n. 6/1979.
Luria A. R. (1928), “Die moderne Psychologie und der dialektische Materialismus”,
Unter dem Banner des Marxismus, 2.
Marx K., Engels F. (1846), L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1967.
Reich I. O. (1968), Wilhelm Reich: biografia da vicino, La Salamandra Milano. 1978.
Reich W. (1920-1925), Scritti giovanili, SugarCo, Milano, 1977.
Reich W. (1922), Il coito e i sessi, SugarCo, Milano 1977.
Reich W. (1925), Il tic psicogeno come equivalente della masturbazione, SugarCo,
Milano,1977.
Reich W. (1925), Il carattere pulsionale, SugarCo, Milano, 1977.
Reich W. (1927), La funzione dell’orgasmo, Sugar, Milano, 1969.
Reich W. (1929), Materialismo dialettico e psicoanalisi, in: A.V. Psicoanalisi e
Marxismo, Samonà e Savelli, Roma, 1972.
Reich W. (1932), «Der masochistiche character», Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse, 3.
Reich W. (1932), “L’irruzione della morale sessuale”, in: A.V., Contro la morale
Borghese, pp. 71-93; Samonà e Savelli, Roma, 1972.
Reich W. (1933), Psicologia di massa del fascismo, Sugar, Milano, 1971.
Reich W. (1936), La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, Milano, 1963.
Robinson P. (1969), La sinistra freudiana, Astrolabio, Roma, 1970.
Sapir I. (1929-39), «Freudismo, Sociologia e Psicologia», in: A.V., Psicoanalisi e
Marxismo, Samonà e Savelli, Roma, 1972.
Vygotskij L.S., Luria A.R. (1925), «Introduzione a: Freud S., Al di là del principio
del piacere (1920)», Rassegna Sovietica,1/1988.